Rivista di formazione e aggiornamento di pediatri e medici operanti sul territorio e in ospedale. Fondata nel 1982, in collaborazione con l'Associazione Culturale Pediatri.
Gennaio 2012 - Volume XV - numero 1
M&B Pagine Elettroniche
I Poster degli specializzandi
Un'asimmetria
oculare degna di nota
U.O.
Oncoematologia Pediatrica, AOUP S. Chiara, Pisa
Indirizzo
per corrispondenza: elenachiocca@hotmail.com
B.
è una bambina di 6 anni che, circa 1 mese prima della nostra
osservazione, inizia a presentare un'asimmetria della rima
palpebrale (Figura
1), notata occasionalmente dai
genitori, associata a disappetenza e tosse secca stizzosa. Per il
persistere della sintomatologia, la bambina
viene condotta dal proprio curante che, mette in evidenza la presenza
di un soffio cardiaco, mai riscontrato in precedenza.

Figura
1.
Viene
quindi eseguita una valutazione cardiologica e all'ecocolordoppler
eseguito si evidenzia la presenza di un versamento pericardico di
discreta entità ( circa 14 mm). Nel sospetto di un'eziologia
infettiva, la bambina viene ricoverata presso l'U.O. di Pediatria
della città di origine dove vengono eseguiti es. ematochimici,
risultati nella norma, ed un Rx Torace con riscontro di slargamento
del mediastino superiore e inferiore con versamento pleurico sx. La
bambina viene quindi trasferita presso l'U.O. di Oncoematologia
Pediatrica del nostro Ospedale. Le condizioni cliniche all'ingresso
sono ottime; B. si presenta apiretica e asintomatica. All'esame
obiettivo risulta evidente l'asimmetria della rima palpebrale; in
particolare a sinistra si evidenzia la presenza di miosi associata a
ptosi palpebrale ed enoftalmo, compatibile
con sindrome di Horner
acquisita. Si evidenzia inoltre una lieve tumefazione parenchimatosa
che dalla regione sovraclaveare sinistra si estende alla regione
laterale sinistra del collo (Figura 2).

Nel
sospetto di una neoformazione a livello del torace si esegue quindi
una TC Torace con riscontro di voluminosa massa mediastinica
anteriore, paramediana sx, estesa dalla regione laterocervicale
inferiore sx fino in sede sovra diaframmatica (diam. Max AP-LL-CC
98X97X169 mm) (Figura
3 e Figura
4). Tale massa, che comprime alla
base del collo il lobo sinistro della tiroide e disloca lateralmente
l'asse tracheale e l'esofago senza segni di infiltrazione locale,
avvolge completamente tutte le strutture vascolari presenti in ambito
mediastinico che mantengono comunque una regolare pervietà
endoluminale. Viene inoltre confermata la presenza di versamento
pericardico e di versamento pleurico a sinistra associato ad
atelettasia passiva del parenchima polmonare contiguo. Si esegue
inoltre un'ecografia del collo che in sede laterocervicale e
sovragiugulare sx apprezza la presenza di tessuto di tipo solido
disomogeneo con diametri di circa 3,5x 2,4 cm che ingloba il fascio
vascolare del collo e impronta il lobo sx della tiroide, nel cui
interno si visualizzano alcuni linfonodi ipoecogeni. Gli altri esami
eseguiti (TC Addome, TC Cranio-Encefalo) risultano negativi.Nel
sospetto di un'origine linfomatosa, B. viene sottoposta in
videotoracoscopia a biopsia della massa il cui successivo referto
istologico conferma la diagnosi di Linfoma linfoblastico a precursori
T. Viene quindi intrapresa la chemioterapia tuttora in corso.
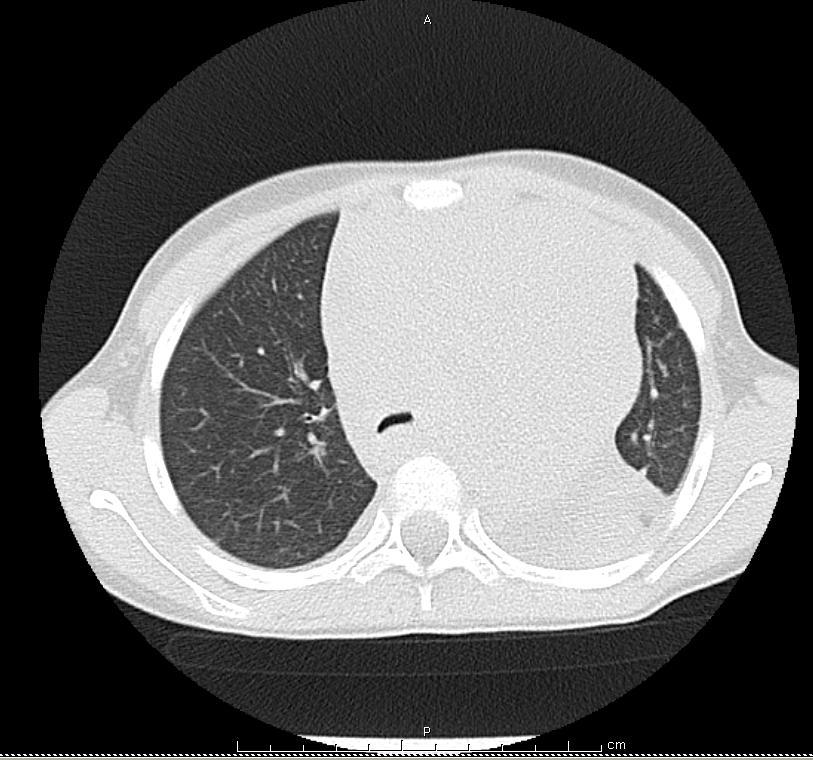

La
sindrome di Horner è causata da una
interruzione della via oculosimpatica
e clinicamente si presenta con la classica
triade caratterizzata da ptosi
palpebrale, miosi e enoftalmo e variabilmente associata a anidrosi,
eterocromia della pupilla e congestione congiuntivale omolaterale. Le
fibre oculo-motrici simpatiche, originate dal centro cilio-spinale di
Budge (C8-D1), attraverso la prima radice toracica e i gangli
cervicali inferiori e medio, si portano come fibre pregangliari al
ganglio cervicale superiore. Le fibre post gangliari si accollano
all'arteria carotide interna ed entrano nell'orbita insieme alla
branca oftalmica del n. trigemino portandosi al ganglio ciliare e da
qui attraverso i nervi ciliari lunghi innervano il muscolo dilatatore
delle pupille e il muscolo tarsale.
La
sindrome può essere quindi determinata da diverse cause che
determinano un'interruzione di questa via in particolare le lesioni
pregangliari si riscontrano nei traumi chirurgici, nella sindrome di
Pancost (tumori dell'apice polmonare), nei traumi neonatali
(deficit a carico del plesso brachiale), aneurismi a carico
dell'aorta e della succlavia, mentre le lesioni postgangliari si
osservano in caso di patologia carotidea e le lesioni centrali in
presenza di lesioni laterali del bulbo, pontine e nei tumori
midollari.L'incidenza della sindrome di Horner nella popolazione
pediatrica è di circa 1.41 casi per 100.000 pazienti, l'eziologia
viene suddivisa classicamente tra cause congenite (circa il 55% dei
casi, corrispondenti ad una prevalenza alla nascita 1:6250 bambini
nati vivi)e cause acquisite. Le forme acquisite possono essere
conseguenze di interventi chirurgici a livello della testa,
collo e torace, dovute a tumori o infezioni che si localizzano a
livello della via oculosimpatica o essere idiopatiche (fino al 33%
dei casi). Sia le forme congenite, ma in particolare, quelle
acquisite, nelle quali non sia possibile identificare un'eziologia
precisa, devono essere attentamente indagate con RMN/TC a livello
testa, collo e/o torace alla ricerca di neoformazioni, processi
espansivi o infettivi.
tratto
da: Confronti Giovani, XXIV
Congresso Nazionale Confronti in Pediatria
Trieste,
Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima 2-3 dicembre 2011
Vuoi citare questo contributo?
