Rivista di formazione e aggiornamento di pediatri e medici operanti sul territorio e in ospedale. Fondata nel 1982, in collaborazione con l'Associazione Culturale Pediatri.
Aprile 2009 - Volume XII - numero 4
M&B Pagine Elettroniche
Pediatria per l'ospedale
L'epistassi
Membro
della Commissione Nazionale Vaccini
Indirizzo
per corrispondenza: bartolozzi@unifi.it
L’epistassi,
cioè la fuoriuscita di sangue rosso dal naso, è
un’evenienza estremamente frequente a tutte le età, ma
soprattutto nel bambino. Il sangue che viene perduto in queste
occasioni sembra sempre molto abbondante, per cui i genitori sono
sempre molto allarmati e portano il bambino dal pediatra. Nella
grandissima maggioranza dei casi la causa dell’epistassi è
semplicemente locale e la perdita di sangue è minima; ma il
pediatra deve conoscerne le cause e deve rassicurare i genitori.
Sul
New England Journal of Medicine del 19 febbraio 2009 è
stata pubblicata una revisione di questa frequente manifestazione: RJ
Schlosser- Epistaxis. N Engl J Med 2009;360:784-9. Ne riporto
i punti principali.
Si pensa
che l’epistassi
si manifesti nel 60% delle persone, nell’arco della loro vita,
ma solo nel 6% dei casi essa rappresenta un problema medico. La
prevalenza è elevata nei bambini in età inferiore ai 10
anni e si fa di nuovo più elevata dopo i 35 anni.
Aspetti
anatomici
Più
del 90% di tutti gli episodi di epistassi avvengono a carico della
parte anteriore del setto nasale, in un’area chiamata locus
Valsalvae o, secondo gli autori anglosassoni, area di
Kiesselbach. Il sangue a questa area giunge dall’arteria
carotide esterna, attraverso la branca superiore labiale dell’arteria
facciale e le branche terminali dell’arteria sfeno-palatina e
infine dall’arteria carotide interna attraverso le arterie
etmoidali anteriori e posteriori. Soltanto il 10% dei sanguinamenti
dal naso avvengono dalle altre parti del setto nasale e dalle pareti
laterali delle narici (il sangue che arriva a queste aree deriva
dall’arteria carotide esterna, attraverso la branca
sfenopalatina dell’arteria mascellare interna) (vedi figura
1).
I
sanguinamenti nasali posteriori sono più comuni nei pazienti
di maggiore età, con un’età media di 63 anni.
Cause
e condizioni associate
Possono
contribuire alla comparsa dell’epistassi sia condizioni
locali, sia generali. È
molto comune, particolarmente fra i bambini, l’epistassi
originata dal trauma legato all’introduzione di un dito nel
naso (mettersi le dita nel naso). L’epistassi si
manifesta anche nel 17-23% dei pazienti che determinano un trauma
nasale usando farmaci per via nasale, come corticosteroidi e
antistaminici: l’incidenza è più bassa nei
soggetti che dirigono il getto lateralmente per ridurre al minimo
l’effetto di questi medicamenti sul setto. Anche l’uso di
sostanze illecite per via nasale (cocaina) può dare epistassi.
Epistassi molto abbondanti si possono avere in seguito a traumi sulle
ossa nasali o sul setto. La deumidificazione della mucosa nasale è
probabilmente la responsabile dell’aumentata incidenza
dell’epistassi, osservata nei mesi invernali, per il soggiorno
in ambienti iperriscaldati. Altri fattori associati all’epistassi
includono le perforazioni del setto, che sono dovute alla mucosa
secca (uso locale prolungato di farmaci vasocostrittori), alle
rinosinusiti virali o batteriche e ai tumori. Vanno anche prese in
considerazione in pazienti con epistassi, le condizioni generali,
associate alle coagulopatie
La
maggior parte delle epistassi deriva dalla parte anteriore del setto
nasale, in un’area, detta di Vassalva (area di Kiesselbach
degli anglosassoni), che riceve sangue dalle branche terminali delle
arterie sfenopalatina, etmoidale e labiale superiore (figura A). Il
sanguinamento posteriore può derivare dal setto nasale o dalla
parete laterale delle narici (figura B) e origina dall’arteria
sfenopalatina, che entra nella cavità nasale attraverso la
parete nasale laterale.
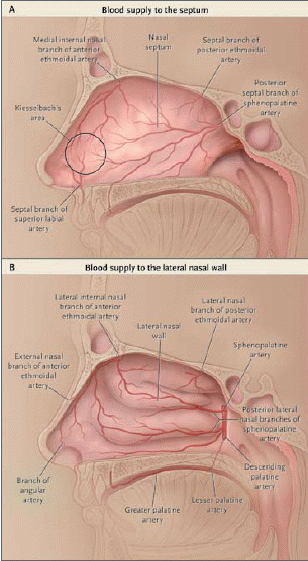
Il 45%
dei pazienti ricoverati per epistassi ha malattie generali, come:
- affezioni genetiche (emofilia A o B)
- coagulopatie acquisite, dovute a malattie epatiche o renali
- uso di anticoagulanti (dicumarolo-warfarin)
- tumori di origine ematologica.
Basse
dosi di aspirina sembrano aumentare di poco il rischio di epistassi;
in un ampio studio in donne in trattamento per la profilassi
cardiovascolare, l’epistassi è stata riscontrata nel
19,1% contro il 16,7% del gruppo placebo, in un periodo di 10 anni.
Anche l’uso di terapie alternative (come aglio, ginkgo o
ginseng) può contribuire a lievi coagulopatie sistemiche, che
conducono all’epistassi.
È
controversa l’importanza dell’ipertensione
nell’epistassi. La teleangectasia emorragica ereditaria è
un’altra situazione genetica che dà epistassi (vedi
figura 2).
L’aspetto
caratteristico della telangectasia ereditaria, a carico dei vasi del
setto anteriore di sinistra (frecce) e del turbinato anteriore di
sinistra (punte di freccia).
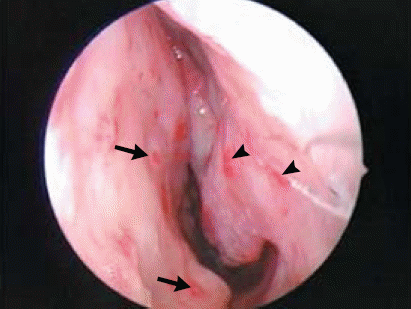
Strategie
e prove
La
valutazione di ogni paziente con epistassi deve iniziare assicurando
una stabilità delle vie aeree e una stabilità
emodinamica. Va sottolineato che quasi nessuna epistassi mette in
pericolo la vita. Solo eccezionalmente sono necessari spray locali
con anestetici e vasocostrittori (come combinazioni di lidocaina e
fenilefrina od ossimetazolina). Questi spray possono essere usati
separatamente o insieme. Inoltre può essere utile
l’applicazione locale di tamponi di cotone, intrisi di farmaci
anestetici e vasocostrittori. L’esperienza indica che questi
sono spesso lenti a fermare l’epistassi; essi inoltre possono
essere usati per togliere i coaguli, al fine di rendere più
sopportabile al paziente l’ostruzione nasale. In caso di
sanguinamento posteriore si rende necessaria, per il trattamento, la
consulenza di un otorino. Spesso si rende necessaria l’iniezione
transpalatina di lidocaina all’1% e di adrenalina 1:100.000,
iniettate lentamente. Quando l’epistassi sia particolarmente
grave, come non si verifica quasi
mai nel bambino, è necessario eseguire un emocromo
completo e la determinazione del gruppo sanguigno, per un’eventuale
trasfusione. In generale non sono da richiedere esami specifici per i
difetti della coagulazione. Esami di laboratorio vanno eseguiti in
paziente che assumono dicumarolo (warfarin) per determinare eventuali
sovradosaggi. Epistassi ricorrenti unilaterali, evenienza
frequente nel bambino, che non risentono dei semplici trattamenti
conservativi, vanno avviate all’otorino.
Tipi
di trattamento
La
maggior parte dei sanguinamenti anteriori sono auto-limitantesi e
non richiedono trattamento medico. Essi possono essere
controllati stringendo la parte anteriore del naso per 15 minuti o
meno. Il paziente va posto in posizione di riposo. La testa può
essere posta sia in posizione piegata anteriore, sia posteriore, a
seconda di come sia più confortevole per il paziente: è
importante che il paziente non ingoi o non inali del sangue, che
viene drenato posteriormente in faringe. Di frequente viene fatto
l’errore di comprimere le ossa nasali, alla base del naso:
invece la compressione va fatta distalmente, comprimendo l’ala
del naso sul setto. Utile l’uso di spray di ossimetazolina. Se
le epistassi sono frequentemente recidivanti o sono refrattarie alla
pressione locale e ai vasocostrittori topici, possono richiedere la
cauterizzazione. Anche in questo caso il paziente va passato
all’otorino.
La
cauterizzazione può essere eseguita:
- con sostante chimiche: nitrato di argento, da usare nei sanguinamenti lievi e quando siano stati identificati i vasi interessati. Quando la cauterizzazione debba essere bilaterale, il trattamento deve essere separato di 4-6 settimane, per permettere la ricostituzione della mucosa.
- I gravi sanguinamenti, che non rispondono al trattamento con sostanze chimiche, possono richiedere una cauterizzazione elettrica, che richiede apparecchiature specializzate.
Il
tamponamento nasale anteriore viene comunemente usato per
fermare le emorragie dall’area di Valsalva, che siano
refrattarie al trattamento sopra riportato. In generale viene usato
un tampone con materiale non degradabile, come una garza o una spugna
di polivinil acetato idrossilato che si gonfia quando bagnata
(Merocel, Medtronic, non in commercio in Italia) o un tampone
gonfiabile (Rapid rhino, ArthroCare, non riportati sull’Informatore
Farmaceutico 2007). Questi tamponi vanno lasciati in situ per 1-3
giorni prima della rimozione. Con questi tamponi il sanguinamento si
ferma nel 60-80% dei casi che non avevano risposto alla pressione e
alla vasocostrizione. L’inserzione e la rimozione di questi
tamponi può portare a un trauma della mucosa con conseguenti
ricorrenti sanguinamenti o dolore. Accanto a questi tamponi è
disponibile una varietà di materiali assorbibili o
biodegradabili, che non richiedono la rimozione e che possono essere
utili per pazienti con o senza coagulopatie (Surgicel, Gelfoam,
Avitene (in commercio in Italia), Floseal e altri). Sia per il
tamponamento nasale anteriore, sia soprattutto per quello
posteriore è necessario l’intervento
dell’otorino. Quando sia applicato un tamponamento è
consigliabile l’uso di unguenti o creme antibiotiche locali o
antibiotici per via generale per timore della sindrome da shock
tossico. Tuttavia l’incidenza di questa sindrome dopo il
tamponamento è molto rara: 16,5 casi su 100.000 tamponamenti
nasali. Quando i trattamenti conservativi non sono capaci di fermare
il sanguinamento, sono necessarie l’embolizzazione o meglio la
legatura chirurgica dei vasi lesi.
Quando
l’epistassi sia controllata, sono in generale raccomandate cure
routinarie della mucosa nasale per prevenire le ricadute. Sono
disponibili gel locali, lozioni e unguenti per promuovere la
guarigione della mucosa: una rivista Cochrane non rileva differenze
fra i trattati con queste sostanze e i non trattati.
Aree
d’incertezza
La
maggior parte degli aspetti del trattamento delle epistassi non è
stato valutato in prove randomizzate, inclusa l’efficacia del
tamponamento da parte del paziente, dei vasocostrittori o di altre
terapie topiche, come il tipo ottimale del tamponamento nasale e la
durata del suo uso, il ruolo degli antibiotici in associazione al
tamponamento nasale, e l’utilità delle varie tecniche
chirurgiche e di embolizzazione.
Linee
guida
Non sono
disponibili linee guida concernenti l’epistassi. Tuttavia le
raccomandazioni della American Academy of Otolaryngology-Head and
Neck Surgery sono in accordo con quanto sopra riportato.
Conclusioni
e raccomandazioni
Nella
grandissima maggioranza dei pazienti con epistassi è
sufficiente il trattamento conservativo, che consiste nella pressione
da parte del paziente della parte anteriore del setto per 15 minuti,
nell’applicazione locale di vasocostrittori e creme idratanti.
Casi che non rispondono al trattamento conservativo rispondono alla
cauterizzazione o al tamponamento con una varietà di materiali
diversi. I casi gravi richiedono un tamponamento posteriore,
interventi chirurgici o embolizzazione. Se avviene una ripetizione
frequente dell’epistassi, va considerata la sospensione della
somministrazione di aspirina.
Vuoi citare questo contributo?
