Rivista di formazione e aggiornamento di pediatri e medici operanti sul territorio e in ospedale. Fondata nel 1982, in collaborazione con l'Associazione Culturale Pediatri.
Novembre 2009 - Volume XII - numero 9
M&B Pagine Elettroniche
Occhio all'evidenza
Lincertezza
della terapia da somministrare
Pediatra
di famiglia Asolo (TV)
Indirizzo
per corrispondenza: dradzik@alice.it
poni
il caso di un uomo che si ammali: chiamerò allora due medici,
ma certamente entrambi avranno opinioni differenti ed io non posso
restarmene con le mani in mano: devo assolutamente fare qualcosa.
Samuel
Johnson
Nelleditoriale1
comparso sul N Engl J Med a commento dellarticolo
sullutilizzo delladrenalina per via inalatoria e del
desametasone per os, nel trattamento della bronchiolite2
Frey e Von Mutius si domandano se le alte dosi di steroide orale
impiegate non comportino il rischio, accanto ai possibili benefici,
di eventi avversi anche gravi. Un bilancio tra effetti favorevoli e
danni, che deve essere sempre tenuto in conto dal medico
proscrittore. Mentre grande attenzione è stata posta finora in
letteratura sulla ricerca della miglior evidenza della ricerca
disponibile, al fine di prendere la migliore decisione clinica, minor
peso è stato invece riservato al modo in cui comunicare al
paziente lincertezza della terapia da somministrare.
Per
cominciare
I
pazienti richiedono di svolgere un ruolo più attivo nelle
decisioni che riguardano la loro salute e sentono sempre di più
la necessità di migliorare il dialogo con il proprio medico:
per arrivare a questo traguardo devono prima di tutto essere
consapevoli e comprendere la loro situazione medica attuale, poi
conoscere gli interventi disponibili, gli esiti attesi del
trattamento proposto ed infine esprimere le proprie personali
preferenze. E tempo ormai che le decisioni mediche diventino
informate (Informed Decision Making in outpatient practice.
Time to get back to basics. Braddock CH. Jama
1999;282(24):2313-20). Informare il paziente e coinvolgerlo nelle
decisioni è dovere primario del medico.
La
decisione deve essere condivisa (sia il processo decisionale che alla
fine la paternità della scelta) = Shared Decision Making. Deve
esistere cioè uno scambio di informazioni da entrambe le parti
(medico e paziente sono partner sullo stesso piano). Secondo alcuni
esisterebbe una differenza sostanziale tra il prendere una decisione
condivisa ed una informata; nella seconda (Informed Decision
Making)il paziente riceverebbe solo una conoscenza dal medico
(unidirezionale), ma è solo lui (lattore)a prendere la
decisione finale.
What
would happen if We have some choices and they are...
was in the doctors habitual script, and Whats
the evidence for that, doctor? in the patients?
William
Godolphin professor of pathology.
Anche la
Cohrane Collaboration nel suo Handbook for Systematic
Reviews of interventions sottolinea il termine decisioni
informate : The Cochrane Collaboration (www.cochrane.org)
is an international organization whose primary aim is to help people
make well-informed decisions about health care by preparing,
maintaining and promoting the accessibility of systematic reviews of
the evidence that underpins them.
In realtà
non esiste nessuna LG che delinei precisamente quanto adeguata debba
essere una decisione per poter essere definita condivisa;
i modelli da adottare variano infatti in base alla complessità
delle strategie da adottare; in generale è possibile
riconoscere 7 elementi importanti, che dovrebbero
contraddistinguere il dialogo fra medico e paziente:
1)
discussione sul ruolo che deve svolgere il paziente nel processo
decisionale (il paziente deve essere invitato a svolgere un ruolo
attivo): es. mi piace prendere questa decisione insieme a lei
2)
discussione sulla natura della decisione: es. le prove cutanee ci
diranno se il suo bambino è allergico
3)
discussione sulle alternative esistenti: es. lei può assumere
il nuovo farmaco o continuare quello attuale
.
4)
discussione sui pro (benefici) e contro (danni) dellintervento:
es. il nuovo farmaco è più caro, ma necessita di essere
assunto soltanto una volta al giorno
5)
discussione sullincertezza associata con la decisione: es. la
probabilità che possa aiutarla è molto alta
.
6)
discussione sulla valutazione della comprensione del paziente a
quello che è stato detto: es. ha capito ?
7)
discussione sulle preferenze del paziente: es. che cosa ne pensa?
Nella
pratica di ogni giorno solo il 16-18% delle discussioni negli
ambulatori del medico di famiglia rispetta i criteri minimi di un
dialogo di questo tipo e solo l1% delle volte si parla di
rischi e benefici per quanto riguarda le decisioni di base e il 17%
per le decisioni complesse.
Se da una
parte la rapida crescita delle conoscenze scientifiche ha spinto a
creare sofisticati sistemi di valutazione dellevidenza, che
viene classificata in base alla sua credibilità, solo da poco
i ricercatori hanno iniziato ad investigare le modalità con le
quali presentare ai consumatori della salute lincertezza dei
risultati ottenuti.
DEFINIRE
LINCERTEZZA
Lincertezza
può essere definita in diversi modi ad esempio ricercando
questa parola nel vocabolario = la condizione di essere indefinito,
indeterminato, non chiaramente identificato e/o non costante. Altra
definizione = stato cognitivo che si crea quando un evento non può
essere adeguatamente categorizzato per mancanza di informazioni. Nel
dominio della salute lincertezza di una malattia rappresenta
lincapacità di prevedere il decorso degli eventi. Nel
campo scientifico lincertezza ha un significato più
tecnico, legato allimprecisione delle misurazioni ovvero
quello che si va a misurare è la Deviazione Standard della
raccolta dei dati ovvero la dispersione dei dati intorno alla media.
Mentre lincertezza rappresenta dunque il range di tutte le
misurazioni, lerrore è la differenza fra il risultato
individuale ottenuto e il vero valore della popolazione.
Possiamo
quindi concludere che esistono diversi modi per definire lincertezza
a seconda dellottica da cui viene osservata e delle fonti da
cui deriva. Sulla base di queste ultime si possono differenziare 5
tipi principali tipi di incertezza:
a) il
rischio o lincertezza degli esiti futuri: la stima del rischio
definisce lincertezza in termini probabilistici, derivando
dallosservazione empirica delloccorrenza di un evento
in una determinata popolazione. Questa ha una però limitata
applicabilità a livello individuale, non importa quanto una
determinata persona sia simile ad unaltra statisticamente
identificata come appartenente ad una determinata categoria. Bisogna
essere consapevoli che lesito di una singola persona non è
conoscibile e può pertanto divergere dal modello categorico.
Gli Intervalli di Confidenza intorno al valore puntuale definiscono
limprecisione della stima, ma non la sua accuratezza. Rischio
= termine utilizzato per comunicare la probabilità e la
gravità di un evento.
b) il
secondo tipo di incertezza si correla non alloccorrenza
dellesito, ma alla qualità dellinformazione
relativa al rischio = ambiguità relativa al rischio.
Lambiguità è alta quando linformazione è
incompleta o conflittuale; essa è in rapporto diretto con la
forza dellevidenza scientifica. Questa è influenzata da
svariati fattori (disegno dello studio, SCR vs osservazionale,
numerosità campionaria, controllo dei fattori confondenti);
linadeguatezza di uno di questi fattori può influenzare
negativamente la validità dei risultatati di uno studio. Gli
SCR forniscono linformazione migliore sulla quale basare
unanalisi; se ci sono svariati studi del genere è
ideale trovare una Revisione Sistematica con meta-analisi.
c)
lincertezza circa il significato personale dei rischi
particolari (la loro gravità, i tempi).
d)
lincertezza che origina dalla complessità
dellinformazione di più rischi presenti
contemporaneamente.
e)
lincertezza che origina dallignoranza; ad esempio molti
medici trattono in maniera superficiale la storia clinica del
paziente, dimenticando in questo modo importanti fattori di rischio.
PROBLEMI
NEL VALUTARE LINCERTEZZA
Esistono
anche delle difficoltà metodologiche nel fornire al paziente
lesatta informazione riguardo al bilancio rischio-beneficio di
un intervento. Ad esempio dare un giudizio che riguarda lincertezza
basandosi sulla p statistica può essere problematico.
-
Lincertezza può essere valutata esaminando lintero
set dei dati (N più ampio, IC più stretti) o un suo
sottogruppo (N più piccolo, IC più ampi). Nonostante il
rischio complessivo possa apparire più preciso di quello
associato ad un suo sottogruppo, unanalisi di sottogruppo può
riflettere in maniera più accurata il rischio relativo ai
membri di quel particolare sottogruppo (ad esempio il tamoxifen
aumenta il rischio di carcinoma endometriale di 2.5 X (RR = 2.53, IC
95% da 1.35 a 4.97) nelle donne in generale. Ma letà è
un effetto condizionante: il RR infatti è di 1.21 (IC da 0.41
a 3.6) fra le donne di età < 51 anni e di 4.01 (IC 95% da
1.7 a 10.9) in quelle di età < 51 anni. In questo caso non
è chiaro quale IC riflette meglio lincertezza
pertinente a quella singola donna.
-
Unaltra difficoltà risiede nel diverso approccio spesso
presente negli articoli per comunicare il rischio (come RR, ARR, NNT)
MODALITA
PER COMUNICARE LINCERTEZZA
La
comunicazione del rischio è un processo interattivo di scambio
di informazioni e di opinioni fra individui, gruppi ed istituzioni.
Comprende messaggi multipli sulla natura del rischio e altri messaggi
che non riguardono strettamente il rischio come lespressione
di preoccupazioni, opinioni.
Perché
si possa attuare è fondamentale che si crei un rapporto di
reciproca fiducia fra medico e paziente, che origina dalla competenza
e dallattenzione (Edwards BMJ 200); entrambe si instaurano
attraverso la conversazione. Lintento del comunicare questi
messaggi è a volte quello di aumentare la coscienza nella
persona che qualcosa di grave potrebbe capitarle, al fine di
spingerla a modificare le sue abitudini per diminuire questa
minaccia; altre volte lintento è quello di migliorare
la comprensione del rischio per aiutare ad ottenere un consenso
informato, che viene visto come tappa fondamentale per prendere una
la decisione migliore. Linformazione probabilistica può
essere offerta utilizzando un formato verbale, numerico, visuale. Ad
esempio ad un fumatore può essere detto che rispetto a un non
fumatore ha un rischio doppio di sviluppare una patologia grave delle
vie aeree, del 20% vs 10% o gli si può mostrare un grafico.
Quando ai
pazienti si forniscono informazioni che riguardono un farmaco, un
intervento chirurgico, il modo in cui viene fornita linformazione
può influenzare grandemente la decisione finale (questo vale
anche per i medici, vedi misure relative vs assolute)
Verbale
Uno dei
metodi più immediati è mediante lespressione
comune: quando parliamo al paziente di probabile, raro, che cosa
veramente intendiamo? Sono parole che possono venir interpretate con
ampia variabilità e ciò le rende un veicolo scadente
per comunicare lincertezza, come si può osservare dalla
figura 1.
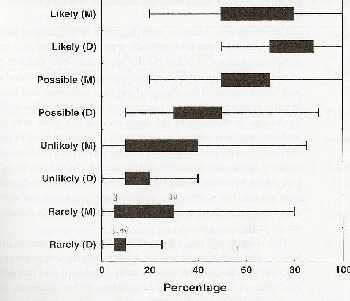
Figura
1. Mediane, range interquartili (box) e range relative alle
percentuali assegnati dalle Madri e dai Dottori alle varie
espressioni verbali quando si chiedeva che cosa significavano per
loro le parole raro, probabile ecc. Da Shaw et al. How do parents of
babies interpret qualitative expressions of probabilità? Arch
Dis Child 1990.
Quiz
1
Le
domande fatte loro:
- il vs
bambino ha littero e dovrà probabilmente essere
sottoposto a fototerapia.
- E
possibile che vs figlio debba essere spostato in Unità
Intensiva.
- E
improbabile che vs figlio possa essere dimesso prima del
week-end.
E
chiaro quindi che queste espressioni soggettive andranno evitate
qualora rappresentino le basi per prendere decisioni importanti
(bambino prematuro con emorragia cerebrale e consenso allintervento
chirurgico). In questo studio la variabilità è
risultata massima nel gruppo delle madri. Queste definizioni
qualitative possono essere giustificate solo quando il medico vuole
essere deliberatamente vago (è possibile che suo figlio superi
la propria disabilità). Un possibile approccio corretto da
parte del medico è quello di far seguire alle parole il range
entro il quale considera possa avvenire levento ( è
improbabile, cara signora, che capiti, diciamo che le probabilità
variano fra il 5 e il 15%).
Lesperienza
personale precedente condiziona il modo in cui viene interpretato
levento probabilistico (es se un paziente ha presentato un
evento avverso tenderà a definire il termine possibile con una
percentuale più alta, rispetto a colui che non lo ha
sofferto)(Woloshin Arch Fam Med 1994).
Numerica
La
comprensione richiede unabilità a comprendere i numeri;
studi di ricerca hanno dimostrato che le persone comprendono meglio
linformazione numerica quando essa è espressa in
termini di frequenza rispetto a quando è indicata come
probabilità
Laccordo
sulle decisioni da prendere aumenta fra i medici quando vengono
utilizzate espressioni numeriche al posto di quelle verbali
(Timmermans, 1994).
Quiz
2
Un
ragazzo di 12 anni arriva nel tuo ambulatorio con sua madre. Da
alcune settimane soffre di un certo grado di rigidità con
lieve dolore, senza causa apparente al suo ginocchi sinistro. Gli
esami del sangue rivelano una concentrazione troppo alta di calcio.
Hai letto recentemente nel NEJM che questa situazione può
essere indicativa di una condizione molto rara (1,5%), la
Malattia di Verlaans; si tratta di un disturbo metabolico che porta
alla deposizione di calcio fosfato nelle articolazioni, come
conseguenza di un assorbimento aumentato di calcio nellileo
distale. I sintomi di solito (70%) compaiono durante
ladolescenza. Questa malattia spesso (65%) inizia a
livello di un ginocchio o di un polso; è progressiva e porta
negli anni ad una progressiva immobilità delle articolazioni.
Necessita di un trattamento farmacologico a vita, che può tra
gli effetti collaterali danneggiare i reni. Questultima
evenienza non può essere esclusa (20%). Decidete di far
eseguire mediante biopsia unesame enzimatico della mucosa
intestinale. Sfortunatamente è possibile (40%), che un
test positivo risulti falsamente positivo; la percentuale di un test
falso negativo è molto bassa (5%). Il test risulta
positivo. Quale pensate sia la probabilità che il ragazzo
abbia questa malattia? Che cosa fareste?
I
pazienti generalmente esprimono il desiderio di avere una
comunicazione del proprio rischio e la maggior parte ne preferisce
una quantitativa; ad esempio oltre metà delle donne
intervistate da Shaw et al dichiarava di preferire lespressione
numerica del rischio, rispetto a quella verbale. E difficile
sintetizzarla con una figura singola, meglio è utilizzare un
range di valori, ma questo richiede che i sanitari sviluppino
delle attitudini a comprendere, valutare e manipolare le informazioni
che riguardano le probabilità.
Alcuni
medici potrebbero chiedersi se luso della probabilità
sia veramente valido perché in realtà il paziente è
unico e le stime della probabilità derivano dallesperienza
di precedenti soggetti o da studi epidemiologici che non possono
venir applicati tous cours ad ogni singolo individuo.
In realtà
quello che è importante per colui che deve prendere una
decisione è lo stato del suo credere attuale e lincognita
del futuro che può venir quantificata.
Lincertezza
può venir espressa quantitativamente in modi differenti: come
probabilità, proporzione, frequenza, percentuale. In ogni caso
anche persone del settore trovano difficoltà a comprendere
pienamente i termini statistici nominati precedentemente.
LUnione
Europea ha delle Linee Guida per descrivere la frequenza di un
evento, con il link fra descrizione verbale e numerica: così
molto comune è > 10% (o > 1 :10) e molto raro
è < 0.01 (o < 1:10000); 4 studi hanno dimostrato che 760
persone invariabilmente sovrastimano grossolanamente queste
espressioni verbali (vedi articolo su Bandolier Costipazione
e pancreatite in cardiopatici che assumono statine).
Chi lo
desidera per approfondire: quiz 3 su
medici e rischio di eventi avversi da vaccino in Bandolier (con
randomizzazione dei questionari) .
Visuale
La
rappresentazione visuale dei dati può facilitare la rapida
comprensione dellespressione numerica dellincertezza.
Un esempio è rappresentato dal box and whiskers della figura
1, i box comprendono il 50% dei dati, le linee (whiskers)
raffigurano il range. La maggior parte delle figure usate cerca di
raffigurare un Intervallo di confidenza intorno alla stima misurata
(rappresentazione dellimprecisione della stima), ma anche
altre misure come il NNT sono state raffigurate. Pochi studi sono
disponibili per verificare quale figura visuale risulta più
comprensibile; uno studio ad esempio ha esaminato 9 grafici che
raffigurano lambiguità nelle previsioni del tempo,
dimostrando che ai lettori erano più familiari le torte e gli
istogrammi, ma non è detto che familiarità equivalga a
miglior comprensione; in ogni caso lattitudine educazionale
del soggetto condiziona la comprensione dei grafici (donne meno
istruite avevano confusione a comprendere le stime e gli IC intorno
alle stime relative alla riduzione del rischio di morte per ca del
seno, mentre signore più colte avevano piacere a prendere
visioni di tali rappresentazioni.
Molti
pazienti e medici sono confusi quando si parla di rischio e di
rapporti rischio/benefici Moore et al. Arthritis Research &
Therapy 2008, 10:R20. Le decisioni si basano sui fatti e sulle
emozioni che possono essere manipolate e non è raro che le
emozioni dominino sui fatti.
Il
successivo è uno dei primi esempi di concentualizzare il
rischio dellassumere sigarette.
Figura
2
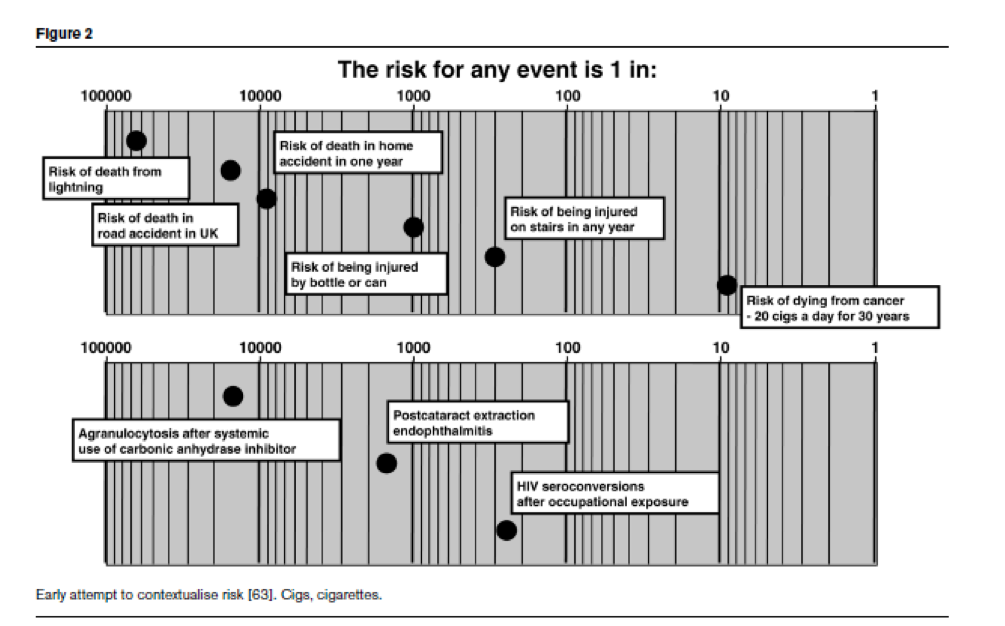
La Paling
Perspective Scale (Scala Prospettiva di Paling) è una
rappresentazione grafica che raffigura i rischi (comprende eventi
naturali) di varia grandezza utilizzando una scala logaritmica: la
presentazione comparativa di diversi rischi aiuta il paziente a
valutare correttamente il rischio per quella data azione (vedi
vaccino vs incidenti, fulmini) (figura 3).
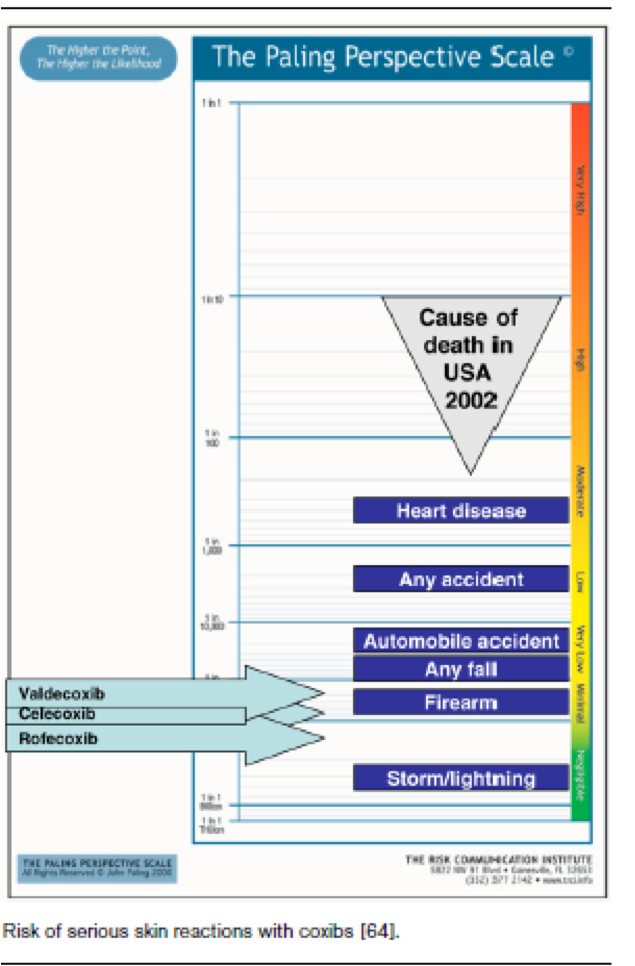
Qui ci
sono sia espressioni verbali che numeriche del rischio; i dati sulla
mortalità vengono presi da ampi studi osservazionali presenti
in letteratura (fare lesempio dei vaccini).
Paling ha
ideato anche le palette di 1000 persone che è utile per
descrivere il rapporto rischio/benefici (esempio aspirina che riduce
il rischio di attacchi cardiaci, ma aumenta il danno (aumenta il
rischio di sanguinamento intestinale), con rischio di morte di 1.10.
Creare la propria paletta collegandosi con http://www.riskcomm.com/
AIUTARE
IL PAZIENTE AD AFFRONTARE LINCERTEZZA
Molti
ritengono che il punto cruciale nella comunicazione del rischio sia
quello di aiutare il paziente a tollerare lincertezza,
piuttosto che di fargliela comprendere appieno, per esempio il medico
deve rassicurare che sarà in grado di rispondere a tutte le
domande relative alla sua salute, che gli consiglierà altre
fonti di informazioni come siti web, che rimarrà aperto e
simpatetico nei suoi confronti, che gli illustrerà tutte le
possibili alternative al trattamento. Altri propongono invece che i
medici dovrebbero chiarire il tipo di incertezza che si dimostra più
stressogena per il paziente (incertezze sulla probabilità,
sulle fonti di informazioni, incertezza sullevidenza) ed
essere in grado di spiegare le complessità relative a ciascuno
di esse.
Bibliografia
1. Frey
U, Von Mutius E. The challenge of managing wheezing infants. N
Engl J Med 2009; 360:20:2130-2233.
2. Plint
AC, Johnson DV, Patel H. Epinephrine and Dexamethasone in children
with bronchiolitis. N Engl J Med 2009;20-2079-2089
Vuoi citare questo contributo?
