Rivista di formazione e aggiornamento di pediatri e medici operanti sul territorio e in ospedale. Fondata nel 1982, in collaborazione con l'Associazione Culturale Pediatri.
Ottobre 2001 - Volume IV - numero 8
M&B Pagine Elettroniche
Contributi Originali - Casi contributivi
Piastrinopenia
cronica multiresistente in bambina con sindrome linfoproliferativa
autoimmune (ALPS). Efficacia della ciclofosfamide
Centro di
emato-oncologia pediatrica , IRCSS Burlo Garofolo, Trieste
Chronic
severe multi-drug resistant thrombocytopenia in a girl with
lymphoprolipherative autoimmune syndrome (ALPS) . Efficacy of
Cyclophosphamide
Keywords:
ALPS Canale-Schmidt syndrome, apoptosi, trombocitopenia,
ciclofosfamide
Il
caso
Chiara è
una bambina di 12 anni affetta da sindrome linfoproliferativa
autoimmune per difetto di apoptosi Fas-indotta (ALPS o sindrome di
Canale-Schmidt), con manifestazioni prevalentemente ematologiche.
La
malattia esordì clinicamente quando Chiara aveva 7 anni con
febbre, poliartrite, nefrite, porpora vasculitica agli arti inferiori
e diarrea emorragica: erano presenti anemia emolitica autoimmune (Hb
5.3 g/dl), piastrinopenia (55.000 plt/mm3), ipergammaglobulinemia
policlonale (IgG 5900 mg/dl, IgA 592 mg/dl), linfocitosi (8.380
linfociti/mm3) ed importante splenomegalia, quest'ultima presente dal
primo anno di vita. L'aspirato midollare e la biopsia ossea eseguiti
in quell'occasione mostrarono un'ipoplasia senza specifiche
alterazioni, mentre la biopsia renale mostrò un quadro di
glomerulopatia mesangio-proliferativa focale. Si trattava dunque di
un quadro di immunoproliferazione associata a diverse manifestazioni
autoimmuni: si richiese la tipizzazione delle sottopopolazioni
linfocitarie, che dimostrò un'elevata percentuale (17.4%) di
linfociti T "doppi negativi" (CD3+ CD4- CD8-). Questo dato,
supportato dal quadro clinico, fece sospettare la diagnosi di ALPS, o
sindrome di Canale-Schmidt, una condizione autosomica dominante
linfoproliferativa non tumorale, legata alla inefficacia della
apoptosi Fas-indotta, cioè alla insufficiente rimozione dei
linfociti attivati in seguito a stimoli anche banali (infezione), e
alla persistenza degli anticorpi (Ig, autoanticorpi) da questi
prodotti. La diagnosi viene confermata dal riscontro di una riduzione
dell'apoptosi Fas-indotta (vedi fig. 1: sulle ascisse viene indicata
la concentrazione dell'anticorpo CH11 utilizzato per stimolare il
recettore FA; sulle ordinate la percentuale di cellule apoptotiche,
identificate dal legame dell'annessina V).
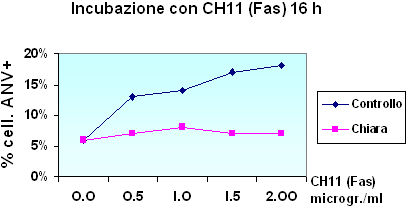
Il padre
di Chiara ed altri familiari del ramo paterno erano stati
splenectomizzati in gioventù per un quadro clinico simile; si
decise di procedere empiricamente sulla base della storia familiare,
sottoponendo la bambina ad un intervento di splenectomia: si ottenne
un rapido e netto miglioramento del quadro clinico con risoluzione
delle manifestazioni ematologiche e nefrologiche; persistevano invece
l'ipergammaglobulinemia e la linfocitosi, indici della disregolazione
immunologica di base.
A
distanza di 3 anni dalla splenectomia, nell'ottobre 1999, comparvero
petecchie agli arti inferiori e gengivorragia persistente associate a
piastrinopenia severa (2000 plt/ml) non preceduta da alcun episodio
infettivo o da assunzione di farmaci. Tale manifestazione ematologica
si rivelò scarsamente responsiva al trattamento con
immunoglobuline e.v. ad alte dosi e con steroidi sia a dosaggio
standard che in boli. Visti gli scarsi risultati ottenuti con le
terapie fino a quel momento adottate e gli effetti collaterali legati
alla terapia steroidea, soprattutto in considerazione della delicata
fase di sviluppo della bambina (peso superiore al 75° centile,
velocità di crescita inferiore al 3° centile,
osteoporosi), si adottarono trattamenti immunosoppressivi maggiori
con fludarabina e con ciclosporina orale che, anche se ben tollerati,
non si dimostrarono efficaci.
Il
problema
La
piccola, ormai in età puberale, a causa dei trattamenti
ricevuti, peraltro apparentemente inefficaci, mostrava una velocità
di crescita <3° centile, un peso >15° centile, una
importate osteoporosi. Né la fludarabina, né la
ciclosporina si dimostrarono efficaci: anzi ricomparvero dopo anni la
artrite e la urticaria vasculitica; si rilevò la comparsa di
anticorpi anti-nucleo e anti-DNA e un calo del C3: una costellazione
laboratoristica che ricordava il LES.
La
soluzione
Fu anche
per questo che si decise un trattamento con ciclofosfamide in boli,
con una remissione dei sintomi clinici e una progressiva risalita
delle piastrine su valori intorno alle 400.000 plt/mmc
Il
contributo
Il caso,
una sindrome autoimmune familiare autosomica dominante, con
produzione di linfociti e anticorpi per mancato controllo da parte
del recettore linfocitario Fas-ligando, è di per se
istruttivo, anche per la comprensione della complessità
patogenetica del fenomeno autoimmunitario. L'evoluzione verso il LES
non sorprende, dato che Il difetto dell'apoptosi mediata dal
recettore Fas è il principale modello animale (nel topo) di
questa malattia. Anzi, si pensa che un difetto dell'apoptosi (o più
probabilmente della clearance delle cellule apoptotiche) abbia un
ruolo nella patogenesi del LES umano. Infatti la maggior parte degli
anticorpi tipici del LES sono rivolti proprio verso antigeni che si
formano in seguito alla degradazione di costituenti del nucleo
cellulare durante l'apoptosi. La comparsa di segni suggestivi di LES
nella bambina (anticorpi anti-DNA, calo del complemento) ha in
quest'ottica una lettura maggiormente istruttiva. E' anche istruttivo
il fatto che una piastrinopenia così severa, che non aveva
risposto a nessuno dei trattamenti classici anche ai dosaggi più
alti e anche in bolo, abbia invece risposto molto bene a un
trattamento con indicazioni specifiche per una particolare malattia
autoimmune, il LES, a sua volta caratterizzata da una costellazione
laboratoristica abbastanaza tipica, simile a quella verso la quale
stava virando la nostra paziente.
L'efficacia
della ciclofosfamide in una condizione simile era d'altra parte già
stata segnalata alcuni anni or sono dal gruppo francese di Alain
Fischer (Lancet 1996;348:719).
Dal punto
di vista eziologico riteniamo che la ricaduta della piastrinopenia
possa essere attribuita alla ridotta apoptosi Fas-indotta, difetto
non modificato dalla splenectomia. E' da rilevare, in tal senso, come
in occasione degli ultimi ricoveri non siano più state
evidenziate né l'ipergammaglobulinemia né la
linfocitosi, markers di malattia: è possibile che la terapia
immunosoppressiva con ciclofosfamide abbia modificato tali parametri
o che Chiara, crescendo, stia andando incontro ad una risoluzione
spontanea della sua malattia, così come descritto in
letteratura.
Vuoi citare questo contributo?
