Rivista di formazione e aggiornamento di pediatri e medici operanti sul territorio e in ospedale. Fondata nel 1982, in collaborazione con l'Associazione Culturale Pediatri.
Novembre 2005 - Volume VIII - numero 9
M&B Pagine Elettroniche
Contributi Originali - Ricerca
Variabilità
del tasso di ospedalizzazione in un gruppo di pediatri di famiglia di
una Azienda Sanitaria Locale della città di Roma
1
Distretto IX ASL Roma C, 2 Agenzia di Sanità Pubblica della
Regione Lazio, 3 Dipartimento ISSTMI ASL Roma C.
Indirizzo
per corrispondenza: capon@asplazio.it
Keywords:
Children, hospitalisation rate, paediatricians, variability
Abstract:
The aim of this study was to evaluate the hospitalisation rates among
patients of paediatricians in a large health unit in Rome. All
hospital admissions between 2001-2003 attributable to the patients of
each pediatrician of the health unit were selected, excluding those
for severe diseases. Hospitalisation rates and average expense due to
hospitalisation per patient were computed. Overall 11.182 admissions
occurred in the whole period among 70.778 children, with an
hospitalisation rate of 5,09 x100 (IC 95% 4,98-5,20) (including
severe diseases: 7,11 x 100 [IC 95% 6,97-7,24]). Single paediatrician
rates showed a large variability (range: 2,49-10,14). Our study
suggests that single paediatrician hospitalisation rate might be a
useful tool to evaluate outpatient health care activity.
Abstract:
Questo studio si propone di valutare la variabilità
dell'ospedalizzazione tra i bambini assistiti dai pediatri di una
ASL di Roma, determinandone il valore per ogni singolo pediatra di
famiglia. Sono stati selezionati i ricoveri acuti in regime ordinario
degli assistiti di ogni pediatra, nel triennio 2001-2003, escludendo
quelli per patologie gravi. Per ogni pediatra sono stati calcolati il
tasso di ricovero e la spesa media dell'ospedalizzazione per
assistito. Su 70.778 bambini assistiti nell'intero periodo, sono
stati osservati 11.182 ricoveri, con un tasso di ospedalizzazione
annuo pari a 5,09 x 100 (IC 95% 4,98-5,20) (includendo i ricoveri per
patologie gravi: 7,11 x 100 [IC 95% 6,97-7,24]). I tassi per singolo
pediatra hanno mostrato un'ampia variabilità (range:
2,49-10,14). Lo studio dimostra che l'ospedalizzazione per singolo
pediatra può essere un indicatore utile alla valutazione
dell'organizzazione delle cure territoriali.
Il tasso
di ospedalizzazione (TO) rappresenta un fondamentale indicatore di
utilizzazione delle strutture ospedaliere, oltre che della domanda
espressa dal territorio. Il suo valore assume particolare interesse
in età pediatrica, per le peculiari caratteristiche dell'età
evolutiva e la conseguente necessaria specificità dei percorsi
organizzativo-assistenziali.
Nel 2001,
in Italia, dai dati ricavati dalle schede di dimissione ospedaliera
(SDO) (1)
il TO nella fascia di età 0-17 anni risultava essere del
10,4%, con notevoli differenze nelle varie fasce di età: (<1
anno: 54,7%, 1-4 anni: 11,1%, 5-17 anni: 7,0%) e nelle diverse
regioni (range: 6,3% Friuli Venezia Giulia – 16,1% Liguria). Pur se
in diminuzione negli ultimi anni, il TO appare più elevato di
quanto si osserva in altre nazioni del mondo occidentale: in Spagna e
in Gran Bretagna sono stati registrati tassi del 5-6% (fascia 0-14
anni) e negli USA si è sceso sotto il 4% (0-15 anni, con
esclusione dei neonati) (1).
Questo
fenomeno, se non giustificato da una particolare epidemiologia di
problemi di salute importanti, presenta varie implicazioni negative,
sia perché determina un aumento della spesa sanitaria, diretta
ed indiretta, sia perché comporta costi sociali e umani
particolarmente accentuati dalla piccola età dei pazienti.
Non
essendo ipotizzabili in Italia condizioni epidemiologiche diverse da
quelle degli altri paesi europei, è presumibile che esso sia
legato ad una consistente variabilità nei protocolli di
accesso in ospedale, ad una differente organizzazione della rete
assistenziale nonché ad una quota di inappropriatezza dei
ricoveri in età pediatrica, come suggeriscono vari recenti
studi (2,3).
L'attuale
Piano Sanitario Nazionale (2003-2005) indica tra gli obiettivi
principali il miglioramento dell'appropriatezza dei ricoveri e la
riduzione del TO in età pediatrica (4).
A questo fine un ruolo determinante spetta alla promozione
dell'assistenza territoriale, attraverso la rivisitazione del
rapporto con l'ospedale, il miglioramento della continuità
assistenziale e la valorizzazione del Pediatra di Famiglia (PdF)
nella definizione dei percorsi più idonei per la gestione
delle varie patologie.
In Italia
sono relativamente poche le ricerche miranti ad individuare gli
eventuali determinanti dell'ospedalizzazione pediatrica, ed in
particolare i rapporti di quest'ultima con l'attività del
pediatra presso cui è in cura il bambino.
Il
presente studio, realizzato in una Azienda Sanitaria Locale della
città di Roma in collaborazione con l'Agenzia di Sanità
Pubblica della Regione Lazio, si propone di stimare i tassi di
ospedalizzazione tra gli assistiti dei pediatri di famiglia della
ASL, valutandone la variabilità e l'associazione con alcune
caratteristiche del pediatra.
La
popolazione in studio è costituita da tutti i bambini di età
0-13 anni assistiti da tutti i 74 PdF con ambulatorio collocato nel
territorio di una Azienda Sanitaria Locale del Comune di Roma (ASL
Roma C) nel triennio 2001-03. Non sono stati inclusi nell'analisi 3
pediatri con un numero medio di assistiti per anno inferiore a 150.
Per
ciascun PdF gli elenchi degli assistiti e le informazioni relative
alle nuove iscrizioni e cancellazioni sono stati forniti dall'Ufficio
Statistico della Regione Lazio. Da questi dati, è stato creato
un archivio finale in cui a ogni record corrispondeva un periodo di
tenuta in carico di un bambino da parte di un pediatra.
I dati
relativi ai ricoveri ospedalieri sono stati ottenuti dal Sistema
Informativo Ospedaliero (SIO), gestito dall'Agenzia di Sanità
Pubblica, che raccoglie tutte le schede di dimissione ospedaliera
degli Istituti di ricovero e cura, pubblici e privati, della Regione
Lazio.
Per ogni
PdF, è stato calcolato il tasso di ricovero tra i propri
assistiti con i rispettivi Intervalli di Confidenza al 95% (IC 95%).
Dall'archivio degli assistiti è stato calcolato il tempo di
presa in carico di ogni bambino da parte del singolo pediatra nel
triennio in studio (2001-2003). Sommando i contributi di tutti gli
assistiti, sono stati definiti i denominatori età specifici
per ogni pediatra (classi di età: 0, 1-2, 3-7, 8-13). Tale
suddivisione per classi di età, diversa da quella standard (0,
1-4, 5-9, 10-13), è stata scelta per garantire una numerosità
simile per singola classe ed ottenere delle stime dei tassi più
precise. I ricoveri sono stati individuati attraverso il linkage tra
l'archivio degli assistiti e quello delle schede di dimissione
ospedaliera. Sono stati selezionati esclusivamente i ricoveri acuti
in regime ordinario; sono stati pertanto esclusi quelli in Day
Hospital e quelli per nascita. Come prima chiave di linkage è
stato utilizzato il codice fiscale, come seconda chiave la
combinazione nome + cognome + data di nascita. Ogni ricovero è
stato attribuito al pediatra presso cui il bambino era iscritto al
momento dell'evento.
Al fine
di permettere un confronto del ricorso all'ospedalizzazione tra gli
assistiti dei singoli pediatri che fosse il meno possibile
condizionato dalla gravità clinica, nel calcolo dei tassi per
singolo pediatra sono stati esclusi i ricoveri per patologie croniche
gravi o acute di origine traumatica (in appendice sono riportati i
codici ICD-IX CM dei ricoveri esclusi).
I tassi
sono stati aggiustati per l'età dei bambini con il metodo
della standardizzazione diretta, utilizzando come popolazione di
riferimento il totale degli assistiti nel triennio. Per ogni
pediatra, è stata anche quantificata la spesa media
dell'ospedalizzazione per assistito, sulla base al tariffario della
Regione Lazio, sia per il totale dei ricoveri che per i ricoveri non
dovuti a patologie gravi.
Sono
stati infine calcolati i TO per distretto di appartenenza del medico
per tutti i ricoveri, e limitatamente ad i ricoveri non gravi, i
tassi per periodo di iscrizione alla convenzione regionale e per
modalità di organizzazione del lavoro ambulatoriale (studio
singolo o pediatria di gruppo).
Il numero
dei bambini in carico ai pediatri in studio (n. 71) è passato
da 53.815 (al 30/06/2001) a 52.216 (al 31/06/2002) ed infine a 51.344
(al 30/06/2003). La
Tabella 1 mostra sinteticamente alcune caratteristiche dei
pediatri per distretto. Solo 3 pediatri del distretto B ricorrono
alla pediatria di gruppo. La media annua di assistiti per singolo
pediatra è stata pari a 737, ma varia sensibilmente nei vari
distretti (da 700 a 788). I pediatri si sono iscritti alla
convenzione in 3 periodi diversi. Il distretto C è quello con
la quota minore di pediatri “anziani”.
Nell'intero
periodo (anni 2001–2003) sono stati assistiti dai pediatri
reclutati 70.778 bambini. Circa 37.000 bambini sono stati tenuti in
carico per l'intero periodo.
Complessivamente,
fra i bambini in carico ai 71 PdF si sono osservati 11.182 ricoveri
(3.827 nel 2001, 3.655 nel 2002 e 3.500 nel 2003), con un tasso di
ospedalizzazione annuo medio nell'intero triennio pari a 7,11 x 100
(IC 95% 6,97-7,24). Il 15% dei ricoveri si è verificato in tre
ospedali interni o al territorio dell'azienda, mentre la
maggioranza (85%) è avvenuta in ospedali esterni all'azienda,
principalmente nell'ospedale pediatrico di riferimento della città
di Roma (39,1%). L'89,2% dei ricoveri è avvenuto in 10
ospedali, 9 dei quali hanno un reparto pediatrico e dispongono di una
consulenza H24 pediatrica in PS. Nessuno degli istituti analizzati
possiede un reparto di osservazione breve.
Il
ricorso all'ospedalizzazione diminuisce all'aumentare dell'età:
il tasso età specifico passa da 16,7 x 100 (IC 95% 16,0-17,5)
per i bambini di età inferiore a 1 anno a 4,0 x 100 (IC 95%
3,8-4,2) per i bambini di età compresa tra gli 8 e i 13 anni.
Sono stati calcolati i tassi aggiustati per l'età dei
bambini e per il distretto sanitario di appartenenza del pediatra.
Solo in uno dei quattro distretti della ASL si è osservato un
tasso significativamente più elevato della media (distretto D:
7,65 x 100; IC 95% 7,41-7,90).
LaTabella
2 riporta la distribuzione dei ricoveri per DRG, distintamente
per DRG medici (76,1% dei ricoveri) e chirurgici (23,9% dei
ricoveri). Tra i DRG medici, il più frequente era il n. 184
(“Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato
digerente età < 18”, 15,3% dei ricoveri medici); mentre
tra i chirurgici era il n. 60 (“tonsillectomia e/o adenoidectomia,
età < 18”, 31,5% dei ricoveri chirurgici ).
Il 72,1%
dei ricoveri (n=8058) era attribuibile a patologie “non gravi”.
Il tasso medio annuo per questi ricoveri è risultato pari a
5,09 x 100 (IC 95% 4,98-5,20). La figura 1 mostra i tassi di
ospedalizzazione senza ricoveri per patologie gravi ed i relativi
intervalli di confidenza al 95% per i 71 pediatri inclusi
nell'analisi. La variabilità fra i tassi dei singoli PdF
risulta molto ampia con un range compreso fra 2,49 e 10,14; nove
pediatri hanno riportato un tasso di ospedalizzazione
significativamente superiore alla media e 10 un tasso
significativamente inferiore (Figura
1).
Tremila-centoventiquattro
(3.124) ricoveri attribuibili a diagnosi “gravi”o riferite a
traumi, pari al 27,9% del totale, sono stati analizzati
separatamente. Il TO medio annuo attribuibile ai ricoveri per
patologie gravi è risultato pari a 2,02 x 100 (IC 95%
1,95-2,09; range dei tassi per singolo pediatra: 1,03-3,51). Tassi
significativamente diversi dalla media si sono osservati per 13
pediatri su 71.
Il costo
complessivo dell'ospedalizzazione, calcolato utilizzando il valore
dei DRG, nell'intero periodo è risultato pari a Euro
20.377.063. Escludendo i ricoveri per patologie gravi la spesa passa
a Euro 12.867.535. Benché nel periodo considerato il numero
complessivo di ricoveri si sia ridotto la spesa è aumentata,
passando da Euro 6.425.307 del 2001 a Euro 7.032.882 nel 2003. La
spesa media annua per assistito per l'ospedalizzazione, riferita
anche agli assistiti che non sono stati ricoverati, risulta pari a
Euro 129,4 per tutti i ricoveri ed a Euro 81,7 per quelli senza
patologie gravi o traumi. Il range per singolo pediatra risulta
essere, rispettivamente nei due gruppi, compreso fra Euro 36 - 222 e
Euro 22 - 161.
Le uniche
informazioni disponibili nell'archivio riferite al pediatra erano
l'anno di iscrizione alla convenzione regionale e la modalità
di organizzazione del lavoro ambulatoriale. Il tasso di
ospedalizzazione è risultato più basso, se pure in
termini non significativi, nel gruppo con anno di iscrizione 1988
(4,92 x 100; IC 95% 4,75-5,10) rispetto ai PdF con maggiore (5,25 x
100; IC 95% 5,07-5,43) e minore (5,10 x 100; IC 95% 4,86-5,36)
anzianità di iscrizione. Fra i 71 pediatri, 3 avevano scelto
di lavorare in forma associata in un unico studio (pediatria di
gruppo) secondo l'Accordo Nazionale Collettivo vigente. Il tasso di
ospedalizzazione in questo gruppo è risultato
significativamente più basso di quello osservato nel gruppo
dei PdF non associati (3,40 x 100 [IC 95% 3,00-3,87] vs 5,16 x 100
[IC 95% 5,05-5,28]). Va sottolineato che nel presente studio non è
stata condotta un'analisi sulle modalità di organizzazione
degli ambulatori pediatrici come ad esempio gli orari di apertura.
Il nostro
studio ha dimostrato una notevole variabilità dei TO fra i
pediatri di famiglia che operano nella stessa ASL. La variabilità
dei tassi per i ricoveri più difficilmente comprimibili,
dovuti a patologie gravi o a trauma è risultata minore di
quella per i tassi attribuibili a patologie non gravi. Il tasso medio
annuale su tutti i ricoveri, nell'intero periodo, fra gli assistiti
dei 71 pediatri è risultato pari a 7,1 x 100. In termini di
raggruppamento diagnostico il DRG in assoluto più frequente è
stato quello per esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie
dell'apparato digerente, indicato tra quelli ad alto rischio di
inappropriatezza per i ricoveri in regime ordinario in assenza di
effettiva urgenza (5).
Molti
sono i possibili determinanti dell'ospedalizzazione pediatrica,
solo in parte legati all'attività dei singoli
professionisti. Essi in qualche modo si inseriscono in uno o più
punti della catena degli eventi che portano il bambino
all'ospedalizzazione: l'insorgenza dell'evento patologico (o
presunto tale), il trasporto presso l'accettazione ospedaliera, il
ricovero da parte di quest'ultima.
In tale
valutazione vanno innanzitutto prese in considerazione le condizioni
intrinseche del bambino, della famiglia e del loro ambiente di vita.
L'appartenenza a famiglie con condizioni economiche svantaggiate o
basso livello di istruzione aumenterebbe l'utilizzazione dei
servizi ospedalieri e i tassi di ricovero, come sembrano suggerire
vari studi (6-9).
Il meccanismo potrebbe essere costituito da una maggiore morbosità
dei bambini, dovuta a mediocri condizioni igieniche o minore
prevenzione, ma anche da un ricorso maggiormente inappropriato alle
strutture ospedaliere favorito dal basso livello di istruzione
(6,10).
Si tratta di fattori non influenzabili da parte del pediatra di
famiglia ma che possono avere un effetto sia sul tasso di
ospedalizzazione su base geografica che su quello del singolo
pediatra.
Nel
nostro studio resta inesplorato il possibile influsso dei
determinanti socio-economici sui tassi di ricovero per pediatra in
quanto sia dalle schede di dimissioni ospedaliere che dall'archivio
degli assistiti mancano informazioni sulle risorse sia culturali che
economiche della famiglia.
Del tutto
estranei alla possibilità di filtro del pediatra sono anche i
fattori legati all'accessibilità dell'offerta ospedaliera
in funzione della residenza del bambino. E' osservazione comune che
i tassi di ospedalizzazione salgono nei gruppi di popolazione
residenti nelle vicinanze di strutture di ricovero. La facilità
logistica ad accedere ai servizi di pronto Soccorso e Accettazione ne
favorisce l'utilizzazione e aumenta la probabilità di
ricoveri inappropriati. Inoltre, va sottolineato il possibile ruolo
di una offerta di posti letto superiore ai bisogni effettivi, tale da
indurre ricoveri non necessari per compensare il basso indice di
occupazione del reparto (11,12).
Il tasso medio complessivo in questo studio (7,1 x100) è
risultato inferiore a quello osservato tra i bambini residenti nelle
altre 4 aziende sanitarie romane nello stesso periodo (9,05%). Ciò
può essere in parte spiegato proprio dalla limitata presenza
di reparti pediatrici nel territorio dell'azienda. La maggioranza
dei ricoveri è avvenuta infatti in istituti esterni
all'azienda. Nell'interpretare questa differenza non sono da
escludere tuttavia, altri possibili fattori legati alle
caratteristiche socio-demografiche della popolazione ed
all'organizzazione dell'assistenza sul territorio, non indagati
in quest'analisi.
Il
pediatra di famiglia può invece assumere un ruolo importante
nell'educazione sanitaria dei genitori, fattore che può
incidere notevolmente nel contenimento della spesa pediatrica.
Infatti, un adeguato comportamento dei genitori in merito alle
vaccinazioni, all'alimentazione e alla cura del bambino riduce
sicuramente l'incidenza delle condizioni patologiche suscettibili
di ricovero così come la meticolosa e puntuale gestione del
bambino patologico ne previene le complicazioni e le ricadute (8).
Inoltre, l'educazione del genitore rappresenta il primo reale
filtro al ricorso improprio alle strutture sanitarie e al ricovero
(11).
Interessanti a questo proposito sono alcune iniziative di
informazione attraverso opuscoli o dépliants distribuiti negli
studi di pediatri di base. Va osservato, peraltro, che sulla
percezione della malattia da parte dei genitori possono incidere
numerosi altri fattori, alcuni individuali (carattere ansioso, età
giovane, ordine di nascita del figlio), altri esterni come ad esempio
l'influsso dei mass-media (6,11).
Il ruolo
di possibile filtro al ricovero da parte del PdF, pure preso in
considerazione da vari autori, non risulta essere sufficientemente
indagato (6).
Sicuramente esiste una consistente porzione di ricoveri che avvengono
senza che il genitore contatti il PdF. Questa quota potrebbe essere
stimata tra il 30 e il 50%, sulla base dei pochi studi disponibili,
peraltro effettuati in genere su ricoveri di urgenza (6,13). Nella
maggioranza di questi casi il contatto col medico non viene nemmeno
tentato dai genitori, per motivi diversi (11,14).
Il bambino, ad esempio, può essere seguito da altro pediatra
privato o specialista oppure dall'ospedale per patologie croniche;
il problema che determina il ricovero può insorgere in giorni
o in orari in cui non è prevista la reperibilità del
pediatra di base; l'evento patologico può essere percepito
come tanto grave o urgente da richiedere l'immediato ricorso
all'ospedale, oppure i prevedibili tempi di intervento del pediatra
possono apparire troppo lunghi; bisogna mettere nel conto, infine, la
possibile scarsa fiducia nella capacità professionale,
disponibilità o reperibilità del medico (6,11,14,15).
E'
presumibile che un buon rapporto di fiducia con il proprio pediatra,
accompagnato da accorgimenti organizzativi miranti a migliorare
l'accessibilità del servizio (ampliamento dell'orario di
reperibilità, eventualmente estesa anche ai giorni festivi,
segreteria telefonica efficiente, disponibilità all'ascolto
e all'intervento) possa facilitare il ricorso al consiglio
preventivo del professionista in una buona quota di questi casi
(6,11).
E' interessante notare che nel nostro studio l'unico gruppo
pediatrico associato (tre pediatri con reperibilità diurna
continua, disponibilità anche festiva e prefestiva – dietro
compenso – e distribuzione ai genitori di dépliants
informativi) mostrava tassi di ricovero nel complesso decisamente
inferiori alla media. Sono infatti diversi gli studi, anche esteri,
che dimostrano il legame tra bassa continuità dell'assistenza
primaria ed eccesso di ricoveri inappropriati (7,8,16) e viceversa
(17).Va però detto che valori di ospedalizzazioni inferiori a
quello medio si sono osservati solo per due dei tre PdF del gruppo
associato, a dimostrazione che il filtro al ricovero garantito dalla
continuità assistenziale può essere condizionato da
altri fattori legati alle caratteristiche del singolo pediatra.
La
percentuale di bambini ricoverati dal servizio di accettazione sembra
essere maggiore se essi sono inviati dal medico curante piuttosto che
vi pervengano in modo autonomo (6).
Tuttavia, non è chiaro in che misura ciò dipenda da una
migliore selezione ed appropriatezza degli accessi al servizio
(efficace filtro del medico curante) oppure da un condizionamento del
medico dell'accettazione. Questa considerazione sposta l'attenzione
sull'appropriatezza dei ricoveri. Tale parametro, esaminato con
protocolli standardizzati (PAEP e PRUO), oscilla in vari studi,
italiani ed esteri, tra il 15 e il 45% delle ammissioni, (8,15,18-21)
ed è fondamentalmente dipendente dalle modalità e dalla
qualità del servizio di accettazione dell'ospedale. E' in
ogni caso presumibile che, a parità di altre condizioni, un
maggiore afflusso al servizio di emergenza possa determinare un
aumento del numero assoluto di ricoveri impropri. Conseguentemente,
un efficace lavoro di filtro del pediatra di famiglia, oltre che
limitare la congestione dei servizi di pronto soccorso e
accettazione, ridurrebbe il numero di errori nelle decisioni di
ammissione. Non va però escluso che il rischio di
inappropriatezza dei ricoveri sia presente anche per gli accessi in
ospedale inviati dal medico curante così come dimostrato da
alcuni studi (19,20).
In
conclusione, questo studio suggerisce alcuni spunti di riflessione
importanti per il miglioramento continuo dell'assistenza pediatrica
sia territoriale che ospedaliera. La diffusione sistematica, a ogni
singolo pediatra, di report annuali sul TO dei propri iscritti,
grezzo e aggiustato per gravità delle patologie, può
fornire un utile strumento per la valutazione dello stato di salute e
dei comportamenti della popolazione assistita. L'analisi del
rapporto tra diverse modalità di organizzazione dell'attività
ambulatoriale (numero di ore di apertura dello studio, pediatria di
gruppo o associativa, etc.) e ricorso all'ospedale rappresenta un
ulteriore approfondimento del fenomeno dell'ospedalizzazione. La
riflessione congiunta tra i PdF e i professionisti del distretto
sull'andamento dei ricoveri può essere utile ad evidenziare
e individuare particolari criticità sia organizzative che
assistenziali suscettibili di miglioramento.
Il nostro
studio suggerisce che gran parte della variabilità fra i
pediatri nel tasso di ospedalizzazione può essere spiegata da
fattori “non clinici”. È evidente e auspicabile che una
riflessione ragionata sulle scelte più efficaci per ridurre il
ricovero in ospedale debba coinvolgere, in un'ottica di
collaborazione e di integrazione, tutti gli operatori sanitari del
territorio, quelli dell'ospedale e le famiglie.
Si
ringrazia il dott. Vincenzo Calia per la preziosa collaborazione
fornita nella fase di definizione del protocollo di studio.
Laddove
l'analisi è stata ristretta a patologie non gravi, sono
stati esclusi i ricoveri con diagnosi principale compresa in questo
elenco (tra parentesi è riportato il codice ICD-IX CM).
L'elenco è stato realizzato in base alla revisione delle
diagnosi degli 11.182 ricoveri analizzati e non è da
considerarsi esaustivo.
- Aids (042)
- Leishmaniosi (085)
- Tumori (189-239)
- Ipotirodismo (244)
- Disturbi di altre ghiandole endocrine(250-259)
- Fibrosi cistica (277)
- Anemia aplastica (284)
- Meningite(320-322)
- Mal ereditarie e degenerative del sistema nervoso centrale (330-339)
- Emiplegia e emiparesi (342)
- Paralisi celebrale infantile (343)
- Altre sindromi paralitiche (344)
- Epilessie (345)
- Distrofie muscolari (359)
- Distacco e rottura della retina (361)
- Cataratta (366)
- Appendicite (540-42)
- Ernia (550-53)
- Malformazioni congenite (741-759) (esclusi se associati a drg chirurgici)
- Traumatismi ed avvelenamenti (800-999)(esclusi perché sono ricoveri difficilmente filtrati dal medico)
1
Ministero della Salute. Le caratteristiche dell'ospedalizzazione
pediatrica in Italia, dal neonato all'adolescente. Disponibile sul
sito: http://www.ministerosalute.it/resources/static/
Primopiano/206/documento.pdf. Accesso del 03-02-2005.
2 Fortino
A., Lispi L., Materia E., Di Domenicantonio R., Baglio G. La
valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri ospedalieri in Italia
con il metodo APPro. 2002. Disponibile sul
sito:http://www.ministerosalute.it/programmazione/resources/documenti/sdo/appro.pdf.
Accesso del 03-02-2005.
3 Agenzia
per i Servizi Sanitari Regionali. DRG a rischio di inappropriatezza –
Analisi delle schede di dimissione ospedaliera. Percentuali di
ricovero ordinario e di Day Hospital. Anno 2002. Disponibile sul
sito: www.assr.it/drg/drg_anno2002.pdf. Accesso del 03-02-2005.
4 Decreto
del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003 – Approvazione del
Piano Sanitario Nazionale 2003-2005. Disponibile sul sito:http://www.ministerosalute.it/psn/psnHome.jsp.
Accesso del 03-02-2005.
5 Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001:
Definizione dei livelli essenziali di assistenza. Disponibile sul
sito: http://www.ministerosalute.it/imgs/
C_17_normativa_226_allegato.pdf. Accesso del 03-02-2005.
6
Clemente A. Rapporti tra il Dipartimento Emergenza-Accettazione e il
pediatra di famiglia: esperienze a confronto. Medico e Bambino.
2000;2:91-94.
7 Parker
JD, Schoendorf KC: Variation in Hospital Discharges for Ambulatory
Care-Sensitive Conditions Among Children. Pediatrics
2002;106:942-948.
8 Flores
G, Abreu M, Chaisson CE, Sun D: Keeping Children Out of Hospitals:
Parents' and Physicians' Perspectives on How Pediatric
Hospitalizations for Ambulatory Care-sensitive Conditions Can Be
Avoided. Pediatrics 2003;112:1021-30.
9
Mandelberg JH, Kuhn RE, Kohn MA. Epidemiologic analysis of an urban,
public emergency department's frequent users. Acad Emerg Med.
2000;7:637-646.
10
Blustein J, Hanson K, Shea S. Preven
11 Del
Torso S, Granzon R, Moretti C, DaDalt L. L'urgenza pediatrica: i
bisogni e le aspettative dell'utente. Medico e Bambino.
2002;3:182-85.
12 Calia
V. L'assistenza pediatrica in Italia. Medico e Bambino.
1998;4:35-41.
13
Escorihuela Esteban R, Barajas Sanchez MV, Dominguez Garrido N,
Fernandez Villalba ME.: Hospital management of pediatric patients
referred from primary care centers. An Pediatr (Barc) 2003;58:327-32.
14 Kini
NM, Strait RT. Nonurgent use of the pediatric emergency department
during the day. Pediatr Emerg Care 1998;14:19-21.
15 Smith
HE, Sheps S, Matheson DS. Assessing the utilization of in-patient
facilities in a Canadian pediatric hospital. Pediatrics
1993;92:587-93.
16
Christakis DA, Mell L, Koepsell TD, Zimmerman FJ, Connell FA.:
Association of lower continuity of care with greater risk of
emergency department use and hospitalization in children. Pediatrics
2001;107:524-29.
17 Esmail
A, Quayle JA, Roberts C. Assessing the appropriateness of paediatric
hospital admissions in the United Kingdom. J Public Health Med.
2000;22:23-38.
18 Bianco
A, Pileggi C, Trani F, Angelillo IF. Appropriateness of Admission and
Days of Stay in Pediatric Wards of Italy. Pediatrics. 2003;112:124-8.
19
Casanova Matutano C, Gascon Romero P, Calvo Rigual F, Tomas Vila M,
Paricio Talayero JM, Blasco Gonzalez L, Peiro S.: Inappropriate use
of pediatric hospitalization. An Esp Pediatr 1999;51:241-250.
20
MacFaul R, Glass EJ, Jones S: Appropriateness of Pediatric admission.
Arch Dis Child. 1994;71:50-58.
21 Formby
DJ, McMullin ND, Danagher K, Oldham DR: The appropriateness
evaluation protocol: application in an Australian children's
hospital. Aust Clin Rev. 1991;11:123-31.
Tabelle
e Figure
distretto | pediatri | n.
medio assistiti nell'anno | periodo
d'iscrizione alla convenzione | |||
totale | pediatria
di gruppo | |||||
1979-85 | 1988 | 1990-96 | ||||
A | 19 | 0 | 708 | 8 | 9 | 2 |
B | 18 | 3 | 700 | 8 | 6 | 3 |
C | 12 | 0 | 788 | 2 | 7 | 3 |
D | 22 | 0 | 764 | 11 | 6 | 5 |
totale | 71 | 3 | 737 | 29 | 28 | 13 |
*
per un pediatra del distretto B non  stata reperita l'informazione
relativa al periodo d'iscrizione alla convenzione.
Tabella
2. Distribuzione per DRG dei ricoveri acuti in regime ordinario tra i
bambini assistiti dai pediatri della ASL RMC. Anni 2001-2003
DRG
medici | codice | n | % |
esofagite,
gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente
eta'< 18 | 184 | 1.299 | 15,3 |
otite
media e infezioni alte vie respiratorie, eta'< 18 | 70 | 695 | 8,2 |
bronchite
e asma, eta'< 18 | 98 | 652 | 7,7 |
convulsioni
e cefalea eta'< 18 | 26 | 570 | 6,7 |
polmonite
semplice e pleurite, eta'< 18 | 91 | 534 | 6,3 |
malattie
di origine virale e febbre di origine sconosciuta, eta'< 18 | 422 | 331 | 3,9 |
altri
fattori che influenzano lo stato di salute | 467 | 236 | 2,8 |
disturbi
della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo eta'<
18 | 298 | 234 | 2,8 |
traumi
della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella eta'<
18 | 282 | 184 | 2,2 |
altre
malattie del sistema nervoso senza cc | 35 | 165 | 1,9 |
altre
diagnosi relative a orecchio,naso,bocca e gola,eta'< 18 | 74 | 154 | 1,8 |
infezioni
del rene e delle vie urinarie eta' < 18 | 322 | 146 | 1,7 |
altri
DRG medici1 | 3.311 | 38,9 | |
totale | 8.511 | 100,0 |
DRG
chirurgici | codice | n | % |
tonsillectomia
e/o adenoidectomia, eta'< 18 | 60 | 841 | 31,5 |
interventi
sul testicolo non per neoplasia maligna, eta'< 18 | 340 | 203 | 7,6 |
interventi
per ernia eta'< 18 | 163 | 165 | 6,2 |
appendicectomia
con diagnosi principale non complicata senza cc | 167 | 158 | 5,9 |
circoncisione
eta'< 18 | 343 | 147 | 5,5 |
interventi
sulle strutture extraoculari eccetto orbita, eta'< 18 | 41 | 116 | 4,3 |
interventi
su tonsille e adenoidi eccetto solo tonsillectomia e/o
adeinoidectomia eta'< 18 | 58 | 101 | 3,8 |
interventi
sul pene | 341 | 98 | 3,7 |
trapianti
di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle o
cellulite senza cc | 266 | 44 | 1,7 |
altri
interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza cc | 270 | 39 | 1,5 |
interventi
sul sistema cardiovascolare per via percutanea | 112 | 36 | 1,4 |
interventi
sul piede | 225 | 35 | 1,3 |
altri
DRG chirurgici2 | 688 | 25,7 | |
totale | 2.671 | 100,0 |
1
diagnosi piu' frequenti in questo gruppo: traumatismi, stati morbosi
mal definiti, tumori
2
diagnosi piu' frequenti in questo gruppo: malformazioni congenite,
traumatismi ed avvelenamenti, malattie dell'apparato digerente,
tumori..
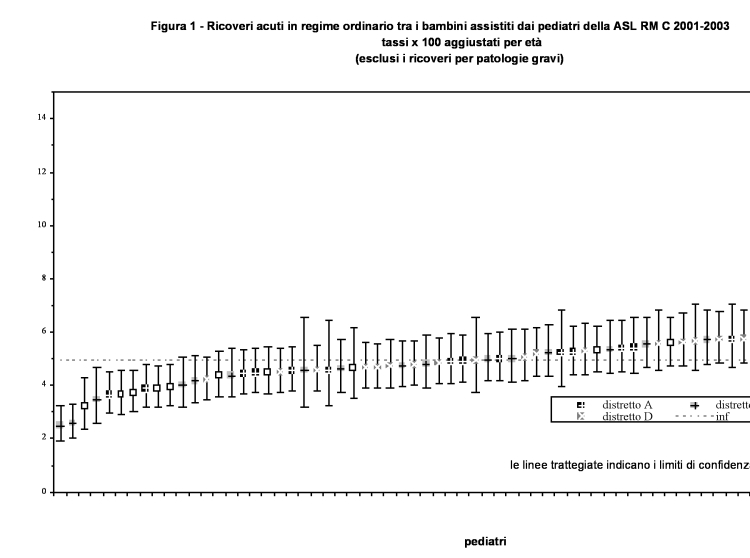
Vuoi citare questo contributo?
