Rivista di formazione e aggiornamento di pediatri e medici operanti sul territorio e in ospedale. Fondata nel 1982, in collaborazione con l'Associazione Culturale Pediatri.
Settembre 2006 - Volume IX - numero 7
M&B Pagine Elettroniche
Contributi Originali - Casi contributivi
Dispnea
inspiratoria in un lattante che non cresce: storia di una cisti
laringea
1SOC
di Otorinolaringoiatria, 2Clinica Pediatrica, 3SOC
di Radiologia, 4SOC di Chirurgia Pediatrica
Istituto
per l'Infanzia, IRCCS “Burlo Garofolo”, Trieste
Indirizzo
per corrispondenza: dott. Domenico Leonardo Grassomimmograsso@hotmail.com
Congenital
vallecular cyst in an infant with failure to thrive and
respiratory distress
Key
words
Congenital
vallecular cyst, Case report
Summary
Congenital
vallecular cysts are rare in neonates and infants. Even though
benign in nature, they own a high potential morbidity and
mortality. Stridor, dyspnoea, feeding difficulties, coughing,
voice changes, failure to thrive are the most common symptoms.
The Authors report a case of a 4 months old infant with failure
to thrive and respiratory distress due to a congenital vallecular
cyst. Marsupialization was performed with complete symptoms
resolution.
|
Le cisti
congenite del laringe costituiscono una rara entità
patologica in epoca neonatale e nei primissimi anni dell'infanzia.
Sebbene si tratti di neoformazioni a carattere benigno, esse
rappresentano, nel bambino, una malattia a elevata morbilità
e/o mortalità1.
Stridore, dispnea, difficoltà nell'alimentazione, tosse,
disfonia e ritardo nell'accrescimento sono i sintomi più
comunemente riportati, simili a quelli che si riscontrano in casi
gravi di laringomalacia2,3.
Nell'adulto, il riscontro di tali neoformazioni è per lo più
incidentale o evidenziato da una sintomatologia più sfumata4.
Le cisti della vallecula glosso-epiglottica originano da ghiandole
sottomucose ostruite e si accrescono in volume in risposta alle
secrezioni ghiandolari5.
Riportiamo
il caso di un lattante di quattro mesi ricoverato per ritardo di
accrescimento e distress respiratorio nel quale è stata
riscontrata una cisti congenita della vallecula glosso-epiglottica.
M. è
un bimbo di 4 mesi nato a termine, parto eutocico, APGAR 9-10, PN
3150 g, allattato al seno sino al primo mese, poi con latte di
formula. La sua storia si caratterizza, dalla nascita,
dall'assunzione di una posizione in estensione del capo associata a
una costante respirazione rumorosa (tipo “gorgoglio”); presentava
inoltre una dispnea con rientramenti giugulari e subcostali con
peggioramento durante il pianto, non associati tuttavia a pianto
stridulo e a raucedine o afonia. A questo si associava un evidente
quadro distrofico, con incremento ponderale di 1 kg in 4 mesi.
L'ipotesi diagnostica che è stata inizialmente formulata è
stata quella di un quadro di laringomalacia.
Al terzo
mese va incontro a un episodio di bronchiolite da VRS risoltosi senza
necessità di ossigenoterapia; durante tale episodio si tenta
un'alimentazione enterale con sondino naso-gastrico con iniziale
incremento ponderale, ma persistenza del vomito.
Al
termine del terzo mese viene ricoverato per la comparsa di vomiti a
getto al termine di ogni pasto. Nuovamente si tenta l'alimentazione
tramite sondino nasogastrico.
Giunge
alla nostra osservazione. All'esame obiettivo appare fortemente
distrofico, non ipotonico, dispnoico, con marcati rientramenti al
giugulo e subcostali (anche a riposo), desaturato (SaO2 94% in
veglia, fino a 84% in aria ambiente durante il sonno), in
atteggiamento di opistotono. Il bambino era molto irritabile e
presentava un colorito grigiastro, senza evidenza di cianosi.
All'ascoltazione del torace l'ingresso di aria risultava essere
lievemente ridotto. L'esame neurologico era nella norma.
L'ipotesi
iniziale è stata quella di una laringomalacia, anche se
colpivano il grave impegno respiratorio (con evidenza all'emogas di
una ipercapnia (PC02: 48 mmHg)), lo stato di denutrizione
riferibile, dalla storia clinica, alla presenza di uno scarso
introito calorico (per la difficoltà nell'alimentazione e il
vomito presente quasi dopo ogni pasto).
Sono
state escluse una cardiopatia e una pneumopatia primitiva (non
evidenza di soffi, radiografia del torace, elettrocardiogramma ed
ecocardio nella norma), un improbabile quadro di malassorbimento
(assenza di grassi nelle feci, elastasi fecale nella norma). Anche
l'ipotesi di una malattia metabolica è stata negata dalla
normalità dell'emogas (non evidenza di acidosi metabolica),
dell'ammoniemia e degli aminoacidi urinari. Non era presente un
quadro di immunodeficienza (non è presente linfopenia; nella
norma le immunoglobuline sieriche e le sottopopolazioni
linfocitarie).
La
presenza del vomito dai primi giorni di vista poteva essere spiegata
dal quadro respiratorio (respirazione con impegno dei muscoli
accessori e sviluppo di pressioni negative); tuttavia era anche
ipotizzabile una intolleranza alle proteine del latte, da possibili
microinalazioni. Di fatto un tentativo empirico di alimentazione con
sondino con idrolisato proteico ha portato a una risoluzione
immediata degli episodi di vomito, con discreta crescita ponderale.
Permanevano immodificati la dispnea con rientramenti e i rumori
respiratori.
La
diagnosi di laringomalacia presentava
alcuni elementi di incongruità:
a.
L'impegno respiratorio risultava essere molto severo e si associava
a una ipercapnia, evenienza questa possibile nei casi gravi di
laringomalacia, ma complessivamente rara;
b.Quello che colpiva di
più era l'assenza del classico stridore inspiratorio con
raucedine (la voce del bambino non era stridula), quasi sempre
presente (anche se non obbligatorio) in presenza di un quadro di
laringomalacia, con presenza invece di rumori in ed espiratori, tipo
gorgoglio.
Il quadro
clinico risultava essere grave, per la distrofia e per il punteggio
clinico relativo all'ostruzione respiratoria (Tabella
I). Vi era l'indicazione per l'esecuzione di una
laringoscopia diretta a fibre ottiche flessibile che ha evidenziato
la presenza di una neoformazione cistica a livello della vallecula
glosso-epiglottica che tendeva a sovrastare l'epiglottide durante i
movimenti respiratori, con accentuazione dell'ostruzione durante il
pianto.
(nota:valori<3
sono da ritenersi tranquillizzanti; >10 impongono corretta
valutazione e approccio terapeutico)
0 | 1 | 2 | 3 | |
Stridore | assente | lieve | moderato | grave |
Colorito | normale | normale
score
0 | normale
score
0 | grigio/cianosi |
Retrazioni
giugulo-diaframmatiche | nessuna | lieve
(se
pianto) | modesta
(a
riposo) | marcata |
Coscienza | normale | irrequietezza | agitazione | letargia |
Ingresso
aria | Normale | lieve
riduzione | moderata
riduzione | marcata
riduzione |
È
stata eseguita una Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) della
neoformazione, con scansioni assiali e coronali con evidenza in
corrispondenza della regione compresa tra base della lingua e faccia
linguale dell'epiglottide di una neoformazione rotondeggiante a
margini netti, omogenea, iperintensa nelle sequenze T2 pesate e
ipointensa nelle sequenze T1 pesate, priva di ehnancement dopo
somministrazione di mezzo di contrasto (Figura 1
e Figura 2).
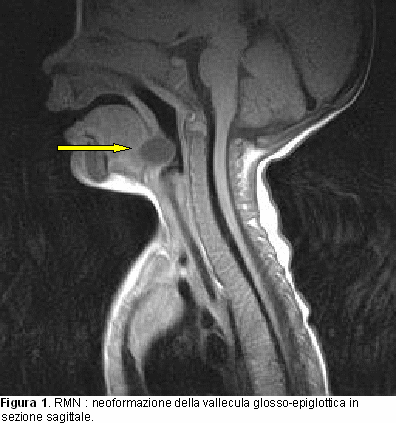
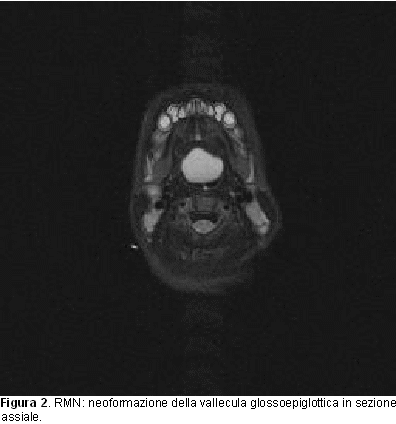
Il giorno
successivo è stata eseguita, sotto controllo endoscopico
rigido, l'incisione della cisti dalla quale è fuoriuscito
abbondante quantità di materiale colloide. È stata
eseguita la marsupializzazione della cisti con exeresi di ampie
porzioni della parete.
La
risoluzione della sintomatologia è stata pressoché
immediata. L'esame colturale della raccolta fuoriuscita dalla cisti
non ha evidenziato alcun microrganismo. Al controllo effettuato la
settimana successiva si poteva osservare la permanenza di un minimo
residuo della parte anteriore della cisti. Al fine di evitare la
comparsa di recidive, dopo 14 giorni rispetto al primo intervento,
veniva eseguita una regolarizzazione dei margini residui con laser a
diodi per via endoscopica. Una settimana dopo, a un nuovo controllo
endoscopico, il quadro obiettivo appariva completamente risolto con
regolare anatomia della vallecula glosso-epiglottica. L'esame
istologico evidenziava la presenza di epitelio pavimentoso
stratificato con fenomeni di fibrosi stromale. Nella parete della
neoformazione erano riconoscibili alcune strutture vascolari con
aspetto emagiomatoide.
Le cisti
congenite laringee sono rare. Mitchell e coll. riportano 5 cisti
valleculari in una casistica di 20 cisti congenite laringee. Hsieh e
coll.6 e Liu e coll.7,
in due casistiche retrospettive, descrivono la clinica e la gestione
diagnostico-terapeutica di 14 e 11 cisti congenite valleculari
glosso-epiglottiche, rispettivamente.
Le cisti
laringee sono distinte in un tipo sacculare e un tipo duttale. Il
primo tipo deriva dal piano sacculare e si pensa che sia secondario
alla distensione di tale struttura. Il secondo originerebbe invece
dal blocco delle ghiandole sottomucose e si riscontra più
frequentemente nella vallecula. Raramente sono stati riportati casi
di cisti della vallecula secondari a infezioni8.
Burton et al. hanno riportato un caso di cisti valleculare in un
paziente adulto causato da un infezione da Nocardia asteroides9.
Nel caso da noi presentato non è stato possibile identificare
alcun microrganismo dal liquido fuoriuscito dalla neoformazione.
Lemanifestazioni sintomatologiche inerenti la cisti della
vallecula glossopeiglottica sono tutte da correlare con l'ostruzione
delle alte vie respiratorie e sono molto simili a quelle che si
riscontrano nei casi di laringomalacia, anche se di solito il quadro
clinico è più severo. Il sintomo caratteristico è
lo stridore inspiratorio pressoché presente in tutti i
pazienti riportati dalla letteratura. Altri segni di distress
respiratorio sono dati da rientramento toracico, episodi apnoici,
tosse cronica, pallore e/o cianosi. In aggiunta, i bambini affetti
possono presentare disfagia, conati di vomito o difficoltà
nell'alimentazione. Tali sintomi vengono esacerbati dalla posizione
supina. Una disfonia o un pianto smorzato possono essere presenti.
Infine, la presenza di un basso peso e di un ritardo
dell'accrescimento possono essere secondari alla presenza di una
cisti della vallecula glosso-epiglottica10.
La
diagnosi differenziale di una massa della vallecula
glosso-epiglottica include la cisti interna del dotto tireoglosso, la
cisti dermoide, tessuto tiroideo linguale, linfangioma e emangioma11.
La laringoscopia flessibile a fibre ottiche, pur essendo essenziale
nell'identificare la presenza della massa valleculare, non riesce a
distinguere tra le diverse entità anatomopatologiche testè
citate. Per tale motivo è indispensabile eseguire
pre-operatoriamente uno studio per immagini della neoformazione che
ne indichi la struttura, i limiti e i rapporti con le strutture
viciniori.
LaTomografia Computerizzata in tali casi si rivela di scarso
valore. Infatti, le cisti valleculari, la cisti del dotto
tireoglosso, la cisti dermoidi, l'emangioma e il linfangioma
appaiono tutti come una neoformazione a bassa densità.
Solamente il tessuto tiroideo linguale si presenta con un segnale ad
alta densità12. Per
tale motivo, la RMN con sequenze pesate in T1 e T2 e con gadolinio ha
assunto un ruolo predominante nella diagnosi delle neoformazioni
della vallecula glosso-epiglottica.
Sono
state proposte diverse classificazioni delle cisti laringee in base
alla loro localizzazione ed estensione. Una di queste suddivide tali
neoformazioni in sacculari, duttali e a origine dai foramina della
cartilagine tiroide8. Arens e
coll.13 hanno introdotto anche
l'aspetto istomorfologico nella classificazione delle cisti
laringee suddividendole in congenite, da ritenzione e da inclusione.
Infine, Forte e coll.14 hanno
proposto una classificazione a parte delle sole cisti congenite sulla
base delle loro peculiarità anatomo-istomorfologiche. In tal
modo vengono così a distinguersi cisti congenite intralaringee
di tipo I con la cisti che rimane all'interno dei confini della
laringe e con la presenza di soli elementi endotermici e quelle a
estensione extralaringea. All'interno di questa categoria è
possibile riconoscere un sottotipo IIa, dove sono presenti solo
elementi endodermici, e uno IIb dove si aggiungono elementi
mesodermici (duplicazione laringotracheale o diverticolo). Il nostro
caso rientra così nel sottotipo IIa per la localizzazione
extralaringea e l'assenza di elementi mesodermici.
Il
trattamento della cisti della vallecula glosso-epiglottica è
prettamente chirurgico. La tendenza alla recidiva è elevata e
l'incisione e drenaggio della neoformazione è destinato a
fallire. Per tale motivo è d'obbligo in questi casi eseguire
una marsupializzazione con bisturi laringei, laser o diatermia. Nel
passato, l'utilizzo del laser CO2 è stato
indicato per la dissezione o per la vaporizzazione dell'epitelio di
rivestimento15. Nel nostro
caso, dopo una prima marsupializzazione con diatermia, si è
proceduto a una revisione dei residui della parete cistica,
regolarizzandone i margini mediante laser Nd-Yag in endoscopia.
L'utilizzo di questa metodica ha consentito una precisa azione
chirurgica con un quasi nullo effetto edemigeno, permettendo di
dimettere il paziente in prima giornata.
Le cisti
della vallecula glosso-epiglottica sono entità patologiche
rare che devono essere ipotizzate in presenza di segni clinici di
ostruzione respiratoria delle alte vie respiratorie (che possono far
pensare ad una possibile laringomalacia) e ritardo
dell'accrescimento. Per tale motivo in pazienti che presentano una
tale sintomatologia, è sempre bene eseguire una laringoscopia
diretta con fibroscopio flessibile che ne escluda la presenza.
- Mitchell DB, Irwin BC, Bailey CM, Evans JNG: Cysts of the infant larynx. J Laryngol Otol 1987;101:833-7.
- Tuncer U, Aydogan LB, Soylu L: Vallecular cyst: a cause of failure to thrive in an infant. Int J Ped ORL 2002;(65):133-5.
- Dahm MC, Panning B, Lenarz T: Acute apnea caused by an epiglottic cyst. Int J Ped ORL 1998;42:271-6.
- Ruben RJ, Kucinski SA, Greenstein. Cystic lymphangioma of the vallecula. Can J Otolaryngol 1975;(4)180-4.
- Myer CM: Vallecular cyst in newborn. Ear Nose Throat J 1988;(67):122-4.
- Hsieh WS, Yang PH, Wong KS, Li HY, Wang EC, Yeh TF. Vallecular cyst: an uncommon cause of stridor in newborn and infants. Eur J Pediatr 2000;159:79-81.
- Liu HC, Lee KS, Hsu CH, Hung HY. Neonatal vallecular cyst: report of eleven cases. Chang Keng I Hsueh Tsa Chih 1999;22:615-20.
- De Santo LW, Devine KD, Weiland LH: Cyst of the larynx: classification. Laryngoscope 1970;80:145-76.
- Burton DM, Burgess LP. Nocardiosis of the upper aerodigestive tract. Ear Nose Throat 1990;69:350-3.
- Gluckman PG, Chu TW, van Hasselt CA: Neonatal vallecular cyst and failure to thrive. J Laryngol Otol 1992;106:448-9.
- Gutierrez JP, Berkowitz RG, Robertson CF. Vallecular cysts in newborn and infants. Pediatr Pulmonol 1999;27: 282-5.
- Tibesar RJ, Thompson DM: Apnea spells in infant with vallecular cyst. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2003;112:821-4.
- Arens C, Glanz H et al: Clinical and morphological aspects of laryngeal cysts. Eur Arch otorhinolaryngol 1997;254:430-6.
- Forte V, Fuoco G James A: A new classification system for congenital laryngeal cysts. Laryngoscope 2004;114:1123-7.
Vuoi citare questo contributo?
